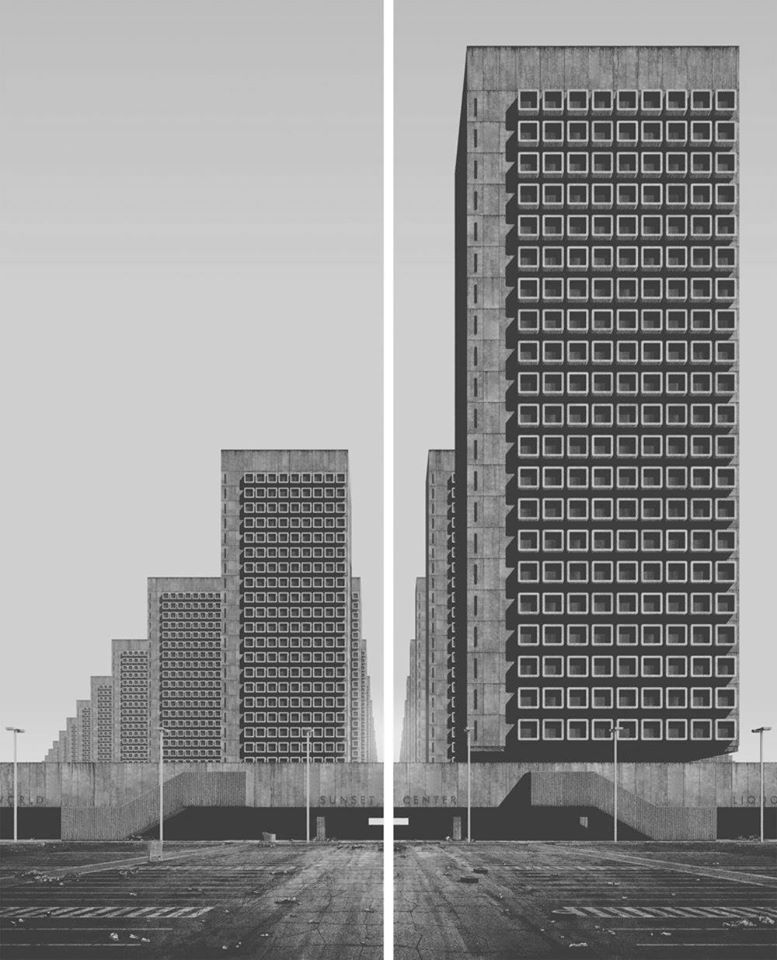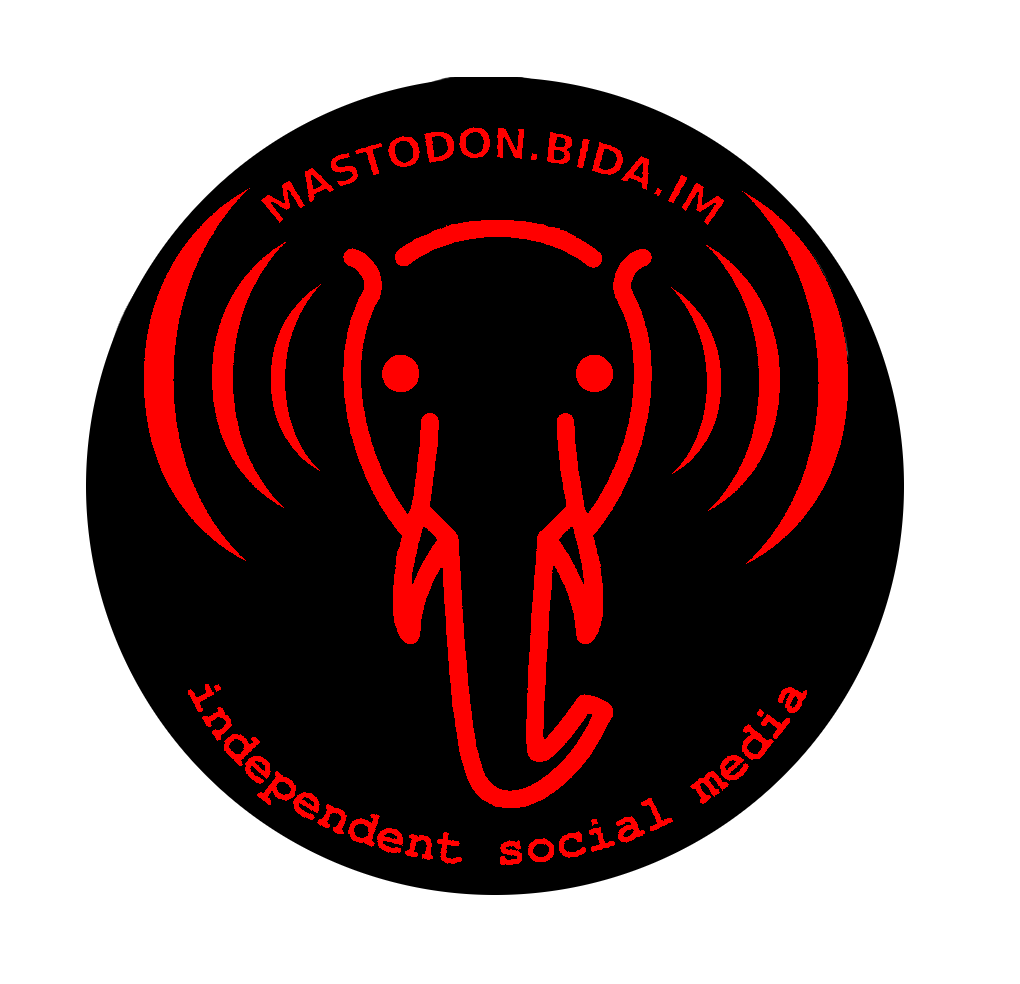Il seguente articolo verrà pubblicato sul numero 27 anno 101 di Umanità Nova
 L’agosto italiano ha visto l’introduzione del Green Pass come strumento per la gestione dell’epidemia. È una misura che era nell’aria da tempo e l’avvicinarsi dell’autunno ne ha accelerato i tempi di adozione. Il Green Pass è una misura che serve allo Stato per scaricare sui singoli le proprie oggettive responsabilità. Non è niente di nuovo: l’intera gestione della pandemia è passata in questa modalità.
L’agosto italiano ha visto l’introduzione del Green Pass come strumento per la gestione dell’epidemia. È una misura che era nell’aria da tempo e l’avvicinarsi dell’autunno ne ha accelerato i tempi di adozione. Il Green Pass è una misura che serve allo Stato per scaricare sui singoli le proprie oggettive responsabilità. Non è niente di nuovo: l’intera gestione della pandemia è passata in questa modalità.
Il governo Conte II, inizialmente, ha sottovalutato la grave situazione pandemica nel Gennaio del 2020, giurando che non c’era nulla da temere e che tutto era sotto controllo; successivamente si è lanciato in una frenetica corsa a decreti restrittivi. I primi focolai non sono stati isolati perché le associazioni degli industriali del Nord-Est si opponevano a zone rosse nei loro distretti produttivi.
Incapace di gestire in modo razionale e scientifico la pandemia, grazie alla storica mancanza di un piano pandemico e ad una medicina territoriale sempre meno adeguata, il governo Conte II ha scaricato tutto sulla gestione dei comportamenti individuali. Al tempo stesso i vertici istituzionali, non riuscendo a fornire un numero sufficiente di DPI, mascherine e gel igienizzanti, sostenevano che le mascherine fossero inutili, sperando, quindi, di abbattere la richiesta di un mezzo di protezione che si è rilevato fondamentale.[1]
Nel frattempo si imponevano misure inutili come il coprifuoco notturno. Incapace di gestire in modo reale la pandemia, il governo, pur di dimostrare che qualcosa sapeva fare, non trovava di meglio che mandare la polizia a prendere i documenti a chi si trovava su una panchina ai giardini. Negli snodi della logistica scoppiavano dei focolai; ma per il governo il problema era regolamentare chi usciva a correre, mica l’espandersi della pandemia nei distretti economici (la cui unica misura di contenimento possibile sarebbe stata il blocco). Fortunatamente il sindacalismo più combattivo e l’auto-organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici sono riusciti, in molti casi, ad imporre stop e blocchi di magazzini e fabbriche in cui vi era l’elevato rischio di contagio.
Il successivo governo Draghi ha continuato sulla stessa linea. La campagna vaccinale è stata prima tarpata da una gestione inefficace e, poi, da una campagna terroristica sul vaccino Astra Zeneca. Ciò si inserisce nella logica delle guerre commerciali tra le varie case farmaceutiche e le rispettive consorterie che appoggiavano questo o quel produttore. Il criminale comportamento dei principali mezzi di informazione, gli stessi che si sperticano in editoriali inorriditi sulle fake news, hanno frenato la richiesta di sieri profilattici da parte di una popolazione sempre più confusa.
Un ardito piano per contenere artificialmente la richiesta di un mezzo atto a soddisfare il bisogno di salvaguardia della salute individuale e collettiva? Oppure l’ordinaria imbecillità della borghesia e dei suoi lacchè? Ai futuri storici la sentenza.
Quale che siano state le cause, questo comportamento ha generato una grave confusione nella popolazione. Un caos in cui gruppi di avventurieri, alla ricerca di consensi politici o di guadagni economici, come i variegati e abietti guru delle pseudoscienze – dai no-vax della prima ora ai propugnatori di farlocche cure domiciliari – sguazzano allegramente. Ora il governo, le televisioni e la carta stampata attaccano questi mestatori che sono le loro stesse creature.
Come culmine di questo periodo di sonora idiozia con il bollino di qualità “Made in Italy”, ecco giungere a noi il Green Pass. Dopo aver terrorizzato la popolazione mezzo stampa, dopo aver dato spazio alle peggiori fandonie antiscientifiche del governo, ecco di nuovo lo scaricamento di responsabilità sulla scelta individuale di vaccinarsi o meno.
Intendiamoci: al momento il ricorso alla profilassi vaccinale è il modo migliore per arginare le peggiori conseguenze della malattia. Il rapporto rischi/benefici è estremamente sbilanciato verso i secondi, checchè ne dicano i precedenti citati guru delle pseudoscienze.
Una profilassi di massa contro le malattie infettive è il modo migliore per impedire l’emergere di varianti. Chi non ne fosse convinto può andare a vedere quante varianti della polio[2] o del vaiolo siano in circolazione al giorno d’oggi, al contrario di metodi terapeutici che, per quanto efficaci sul breve termine, possono operare pericolose selezioni a collo di bottiglia, come già sta accadendo per certe infezioni batteriche a causa dell’uso smodato degli antibiotici in ambito zootecnico.
Al netto di questo si deve fare una riflessione su come la salute sia gestita in una società dominata dal capitale.
La disarticolazione dei sistemi di medicina territoriale ha portato alla perdita del rapporto di fiducia tra medici e pazienti. A questo ha contribuito il comportamento di molti medici: pensiamo ai classici giochetti del tipo “ti seguo meglio quando sei ricoverato in reparto anche se sei un mio paziente privato”, alle operazioni inutili fatte in regime di convenzione da parte di strutture private per drenare più soldi al sistema pubblico, sulla pelle dei pazienti stessi. Il personaggio del dottor Guido Tersilli interpretato da Alberto Sordi nei due film omonimi (diretti il primo da Zampa e il secondo da Salce) è la rappresentazione massima di questo squallore vigente da liquidare senza sé e senza ma.
Lo Stato si sta ora ponendo come l’unico mezzo di salvezza. Come un deus ex machina, l’istituzione statale sa distribuire il vaccino che porterà alla fine dalla pandemia. Ma non è così. Dietro a questa rappresentazione – e, ancora, c’è da chiedersi quanto ci sia di malafede e quanto ci sia di falsa coscienza – si nasconde un nudo fatto: lo Stato non è capace di soddisfare il bisogno di salute. E non è che non ne è capace perché è male organizzato o diretto da personaggi imbecilli o di dubbia moralità. No, non ne è capace perché non è il suo compito. Lo Stato serve a garantire la riproduzione del sistema in cui viviamo. Serve a schiacciare con violenza le persone sfruttate e tenerle in tali condizioni.
L’epidemia di SARS – COVID-19 è solo la prima. Ce ne saranno altre. Se va bene saranno malattie fastidiose ma relativamente poco pericolose. Se va male saranno malattie con la mortalità del SARS-CoV-1 del 2003 o peggio.
 Le pandemia che si profilano all’orizzonte sono dovute a zoonosi. E queste hanno come causa prima la compressione delle nicchie ecologiche dove certi agenti patogeni erano isolati. La distruzione degli ecosistemi, l’esistenza di incubatori a crescita esponenziale come gli allevamenti intensivi o i wet market hanno portato alla proliferazione di determinati micro-organismi. Si può discutere se l’origine della pandemia di COVID-19 sia stata nel wet market di Wuhan (grazie a qualche borghesotto con la sua fame di specie esotiche da mettersi a tavola per rimarcare il suo status sociale), o nel laboratorio di virologia che ha seguito con leggerezza le procedure di manipolazioni di materiale pericoloso – le ipotesi di un virus inventato artificialmente si sono già dimostrate come infondate e quindi non le prendiamo in considerazione. Ma rimane un fatto che in molti cercano di nascondere: l’attuale pandemia non è un mostro venuto dallo spazio profondo: è la diretta conseguenza del nostro mondo. Ed era da anni che si sapeva che prima o poi sarebbe successo.[3]
Le pandemia che si profilano all’orizzonte sono dovute a zoonosi. E queste hanno come causa prima la compressione delle nicchie ecologiche dove certi agenti patogeni erano isolati. La distruzione degli ecosistemi, l’esistenza di incubatori a crescita esponenziale come gli allevamenti intensivi o i wet market hanno portato alla proliferazione di determinati micro-organismi. Si può discutere se l’origine della pandemia di COVID-19 sia stata nel wet market di Wuhan (grazie a qualche borghesotto con la sua fame di specie esotiche da mettersi a tavola per rimarcare il suo status sociale), o nel laboratorio di virologia che ha seguito con leggerezza le procedure di manipolazioni di materiale pericoloso – le ipotesi di un virus inventato artificialmente si sono già dimostrate come infondate e quindi non le prendiamo in considerazione. Ma rimane un fatto che in molti cercano di nascondere: l’attuale pandemia non è un mostro venuto dallo spazio profondo: è la diretta conseguenza del nostro mondo. Ed era da anni che si sapeva che prima o poi sarebbe successo.[3]
Eppure nessuno Stato ha preso precauzioni. Anzi. L’estrattivismo è stato ampiamente incoraggiato, nonostante sia una delle cause prima della distruzione degli ecosistemi. Lo sviluppo di allevamenti intensivi è continuato. Non è un caso che un governo come quello brasiliano sia stato in prima linea nel negare la gravità della situazione. La distruzione delle foreste pluviali è una delle prime fonti del PIL di quel paese. L’ideologia degli evangelici pentecostali al governo calza come un guanto al sistema economico che gestiscono. Le comunità indigene che vengono massacrate dal SARS-COVID-19, come coloro che vivono ammassati negli slums, muoiono per volontà di Dio. I conti in banca dei latifondisti crescono per volontà di Dio. Tutto si tiene.
Inutile aggiungere che ben poco si sta facendo per organizzare una profilassi che avvenga congiutamente a livello globale. I vaccini, o meglio la capacità di produzione degli stessi, sono una leva geopolitica, per cui, al netto della lentezza nell’implementare nuove linee di produzione, che può essere superata fino a un certo punto, vi sarà una scarsità artificiale che renderà possibili varianti in grado di aggirare la proteziane data dalla vaccinazione.
Abbiamo divagato, torniamo alle nostre latitudini. Grazie alle leggi sull’immigrazione italiane, che si inseriscono nel più generale quadro europeo, in Italia ci sono centinaia di migliaia di persone sconosciute al sistema sanitario in quanto irregolari. Altre sono state marginalizzate in quanto persone transgender e “non binary”, senza casa, sex workers, soggetti psichiatrizzati (o un mix di tutte le cose). Queste persone, a volte espulse dai processi produttivi e relegate alle economie informali, non sono state minimamente coinvolte nella campagna vaccinale se non per buona volontà di qualche associazione o di qualche presidio sanitario. Ora, persone senza documenti o non conformi alla loro identità di genere, si troveranno ad aver bisogno dell’ennesimo pezzo di carta cui non hanno accesso a prescindere dall’essersi vaccinate a meno. È il caso di non vaccinati a prescindere dalla loro volontà, o meno, di vaccinarsi dato che burocraticamente non esistono – o esistono solo per questure e prefetture – e quindi non possono accedere alla profilassi.
Forse chi si sta domandando come cavalcare quelle piazze di piccolo e medio borghesi indignati – specie ristoratori – perché, per la prima volta nella loro vita, si trovano dalla parte sbagliata delle decisioni governative, dovrebbe ragionare come organizzarsi con – e sottolineiamo la preposizione con – chi subisce l’ennesima discriminazione.
Certo, tra chi è sceso in piazza ci sono anche molti che sono genuinamente preoccupati, che non hanno posizioni antiscientifiche a priori, che hanno paura, quella paura suscitata da mesi e mesi di terrorismo mediatico e di decisioni contraddittorie da parte del famigerato Comitato Tecnico Scientifico, che di tecnico e di scientifico ha poco, mentre ha molto di politico. Ma la direzione di quelle piazze, chi le cavalca e le dirige, è tutta in mano a pezzi della piccola e media borghesia e dei loro referenti politici.
Come dicevamo, il governo e i media ad esso allineati hanno attivamente boicottato la campagna vaccinale per cui ora spingono. Questo atteggiamento è solo apparentemente contraddittorio. In un dato momento era necessario comprimere artificialmente la richiesta di sieri per nascondere, dietro una cortina fumogena di titoli a cinque colonne, i malori e i morti che ben poco avevano a che fare con il vaccino ma che rientravano nel triste computo della caducità della vita, delle guerre commerciali e della cattiva organizzazione della campagna vaccinale. Ora è necessario interrompere i ristori per certe categorie ed evitare un nuovo brusco stop ai consumi in autunno; per cui si spinge sulla campagna vaccinale stessa.
Inoltre è palese la volontà delle associazioni padronali di porre fine allo smartworking che, pur con tutte le criticità evidenziate da molti dipendenti, ha permesso di limitare i contagi. D’altra parte lo smart working rende molto più difficile la sorveglianza continua degli impiegati e delle impiegate da parte dei capi e capetti negli uffici. Certo, esistono sofisticati sistemi di monitoraggio remoto; ma nelle PMI italiane si preferisce, si sa, gli investimenti in sistemi IT sono ben scarsi per cui sono i sistemi di controllo remoto per i dipenti sono stati adottati, fortunatamente, da ben poche imprese.
Come ciliegina sulla torta è stato annunciato che i giorni di isolamento fiduciario in caso di positività al SARS-COVID-19 (misura che ha permesso di limitare fortemente i contagi), non saranno riconosciuti e pagati come malattia. In pratica stai a casa bruciandoti le ferie o, se hai un contratto atipico, preparati a stringere la cinghia. O in una specie di smart-working che assomiglia più ai domicialiri che ad altro se si lavora in ufficio.
Questo è un gravissimo attacco nei confronti dei lavoratori, che scarica i costi della pandemia – o per meglio dire della sindemia – sui singoli lavoratori. Niente, ovviamente, è stato fatto per abbattere i rischi di contagio in itinere, ovvero sui sovraffollati mezzi pubblici. Questi sono temi su cui è necessario confrontarsi.
Il non-detto sulla questione vaccinale è come tale profilassi metta al riparo dalle peggiori conseguenze della malattia e diminuisce fortemente il rischio di trasmissione – il che è ottima cosa – ma non costituisce uno schermo magico che rimbalza i virus. Per cui anche se sei vaccinato, rischi di essere positivo e di passarti mezzo mese senza stipendio.
Lo Stato sta presentando il vaccino come cura definitiva della pandemia quando in realtà sta solamente cercando un modo di gestione che permetta di trovare un punto di equilibrio tra crescita economica – o per lo meno un non-tracollo economico –, e il numero di morti per la malattia. I guru delle pseudoscienze e i loro seguaci sono solamente l’altra faccia della medaglia, impegnati in una guerra di opinione e nel posizionarsi al meglio nello spettacolo vigente.
Nel frattempo niente si sta facendo per prevenire la prossima pandemia.Dato che gli Stati e il capitale, e tanto meno i ciarlatani, non potranno farlo sarà compito altrui.
NOTE
[1] Sulla rivista scientifica multidisciplinare PNAS (acronimo di “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”) venne pubblicato l’articolo “An evidence review of face masks against COVID-19” (Issues 118, n. 4, 26 Gennaio 2021). In esso, i ricercatori e le ricercatrici analizzano come il virus in questione si trasmetta attraverso le goccioline respiratorie e una delle prevenzioni per frenare la diffusione del contagio sia l’utilizzo delle mascherine. Gli studiosi e le studiose in questione, inoltre, raccomandano “che i requisiti per l’uso della maschera siano implementati dai governi o, quando i governi non lo fanno, da organizzazioni che forniscono servizi rivolti al pubblico. Tali mandati devono essere accompagnati da misure per garantire l’accesso alle mascherine, possibilmente compresi meccanismi di distribuzione e razionamento in modo che non diventino discriminatori. Dato il valore del principio del controllo alla fonte, soprattutto per le persone pre-sintomatiche, non è sufficiente che solo i dipendenti indossino la mascherina; anche i clienti devono indossare le mascherine. […]”
Link all’articolo completo: https://web.archive.org/web/20210904094921/https://www.pnas.org/content/118/4/e2014564118
[2] Le varianti della poliomielite conosciute sono di tre tipi. Attualmente il tipo 3 (Wild PolioVirus 3 (WPV3)) è stato eradicato, mentre il tipo 1 e tipo 2 (rispettivamente WPV1 e WPV2) sono presenti in trentadue paesi (dato del 27 Agosto 2021). La causa della presenza dei primi due tipi di polio è da imputare sia alla bassa qualità di risposta a livello immunitario del vaccino mOPV2 che all’attuale pandemia da Sars-Covid 19. Attualmente l’OMS sta puntando al vaccino nOPV2 come sostituto dell’attuale vaccino. Fonti:
“Eradicazione del poliovirus selvaggio di tipo 3: la certificazione OMS”, 7 Novembre 2019, Link all’articolo completo: https://web.archive.org/web/20210305103236/https://www.epicentro.iss.it/polio/eradicazione-poliovirus-selvaggio-tipo-3
“Progress Toward Polio Eradication — Worldwide, January 2019–June 2021”, Centers for Disease Control and Prevention, Issues 70, n. 34, 27 Agosto 2021. Link all’articolo completo: https://web.archive.org/web/20210831141603/https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034a1.htm?s_cid=mm7034a1_w
“Implementation of novel oral polio vaccine type 2 (nOPV2) for circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) outbreak response: technical guidance for countries”. Link al documento: https://web.archive.org/web/20210817140636/https://apps.who.int/iris/handle/10665/333520
[3] Per chi volesse approfondire il tema delle zoonosi e delle loro cause consigliamo la lettura di Spillover. L’Evoluzione delle Pandemie di David Quammen, edito da Adelphi nel 2017. Sempre su questi temi, consigliamo le lettura dell’articolo “Mai la merce curerà l’uomo”, reperibile qua: https://umanitanova.org/mai-la-merce-curera-luomo-e-figuriamoci-se-lo-fara-lo-stato/