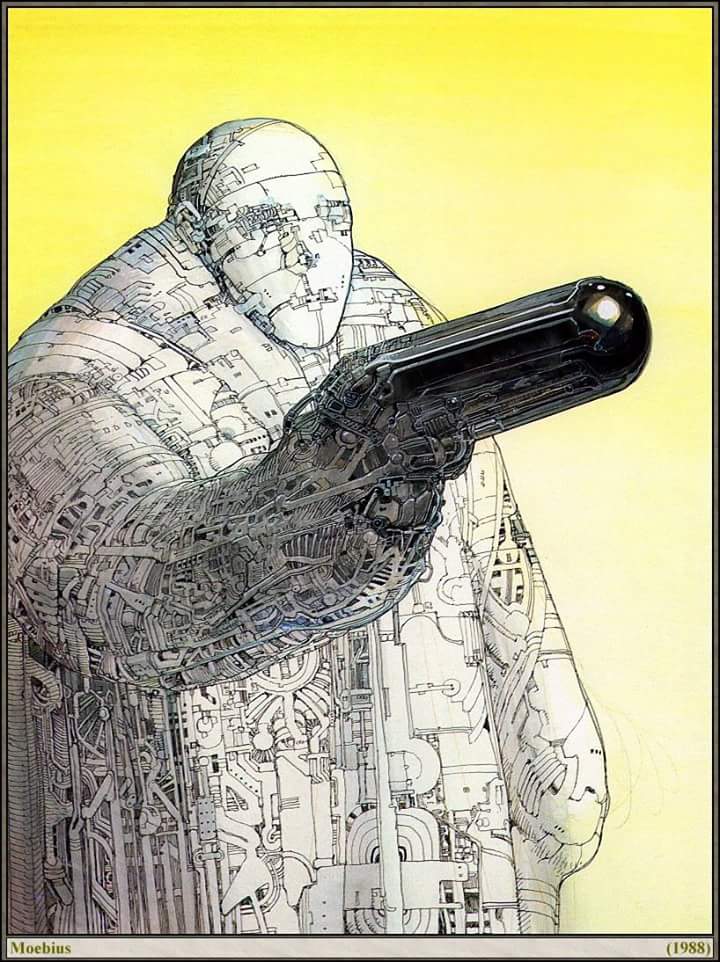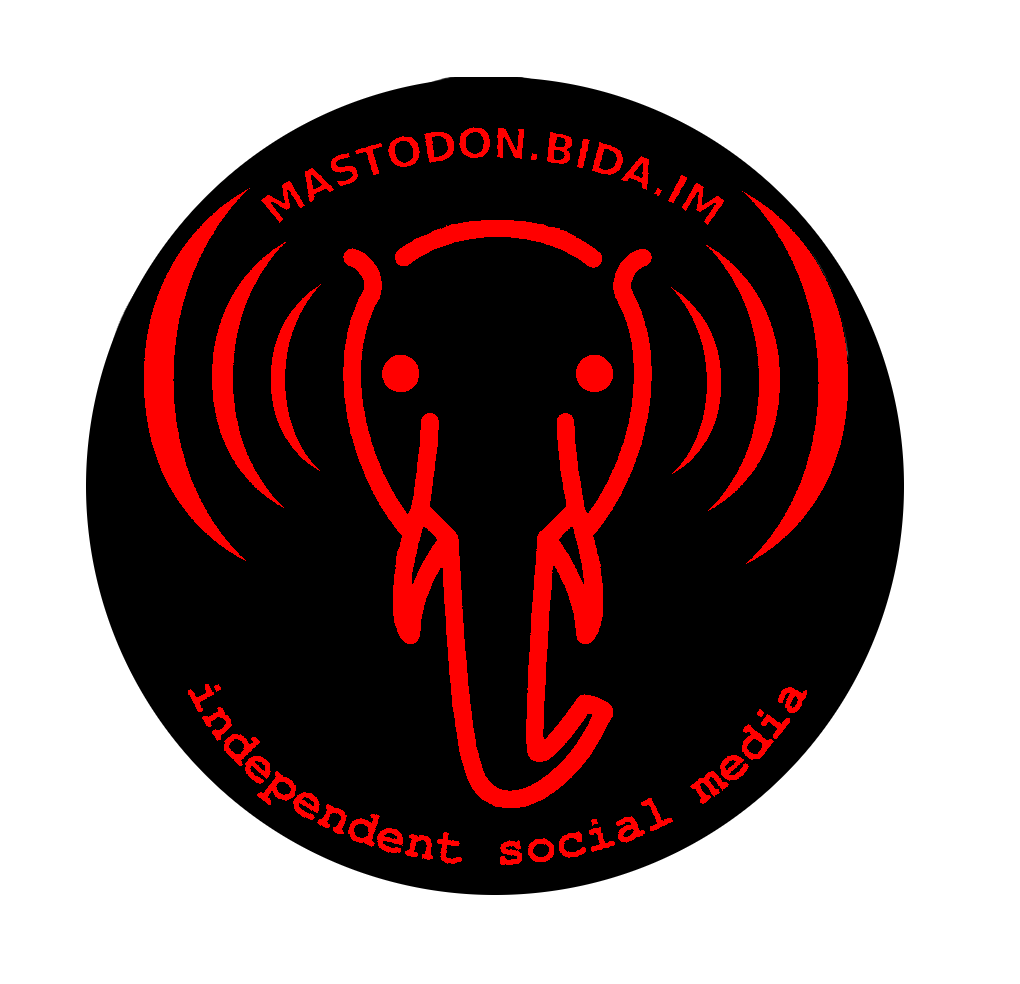Il seguente articolo, scritto dal sottoscritto e da J.R. è stato pubblicato su Umanità Nova numero 3 anno 100
 Esiste un nesso tra la colossale campagna mediatica sulla crisi climatica ed il tentativo di salvare il capitalismo con una pennellata di verde? La risposta è senza dubbio affermativa. Sembra che come per incanto anche molti tra i più incallit inegatori del global warming si siano destati da una sorta di torpore e si preoccupino della crisi climatica. In realtà la loro unica preoccupazione è, e rimane, la crisi del capitalismo occidentale, il quale stenta a riprendersi dopo la catastrofica crisi del 2008. I “rimedi” fin qui adottati non hanno dato molti risultati, l’austerity ed il ricatto del debito hanno sicuramente dato ossigeno ai mercati finanziari, ma la cosiddetta “economia reale” fatta di produzione, vendita e consumo, rimane ferma per una lunga serie di motivazioni incrociate, delle quali il collasso del 2008 è stato solo l’innesco che ha fatto detonare la bomba.
Esiste un nesso tra la colossale campagna mediatica sulla crisi climatica ed il tentativo di salvare il capitalismo con una pennellata di verde? La risposta è senza dubbio affermativa. Sembra che come per incanto anche molti tra i più incallit inegatori del global warming si siano destati da una sorta di torpore e si preoccupino della crisi climatica. In realtà la loro unica preoccupazione è, e rimane, la crisi del capitalismo occidentale, il quale stenta a riprendersi dopo la catastrofica crisi del 2008. I “rimedi” fin qui adottati non hanno dato molti risultati, l’austerity ed il ricatto del debito hanno sicuramente dato ossigeno ai mercati finanziari, ma la cosiddetta “economia reale” fatta di produzione, vendita e consumo, rimane ferma per una lunga serie di motivazioni incrociate, delle quali il collasso del 2008 è stato solo l’innesco che ha fatto detonare la bomba.
Da un punto di vista ecologico l’Occidente si sta inverdendo in quanto sta inquinando allegramente Asia ed Africa: ciò è stato possibile grazie al processo di integrazione globale (meglio noto come globalizzazione) ed alle sue infrastrutture commerciali e di comunicazione, le quali hanno reso economicamente vantaggioso delocalizzare la produzione in aree nelle quali diritti dei lavoratori e leggi sulla salvaguardia ambientale sono tutt’ora un concetto astratto. Se quindi da un lato interi comparti industriali hanno preso il volo verso altri lidi, ciò che rimane è un esubero di forza lavoro difficilmente ricollocabile, sia per ragioni quantitative sia per ragioni qualitative.[1] Un bel “cambiamento strutturale” nel senso che si cambiano gli ingranaggi del sistema per renderlo efficiente non per cambiarne la natura, potrebbe rimettere in moto questo vetusto carrozzone.
Se analizziamo le ragioni del cambiamento climatico e dell’impatto sulle risorse ambientali, potremo osservare che non basta ridurre le emissioni di gas serra nel comparto produttivo: bisognerebbe che questa riduzione fosse accompagnata da una regolamentazione del consumo di risorse. La svolta verde però si occupa quasi esclusivamente di ridurre l’uso di combustibili fossili senza mettere in discussione il modello economico basato su di una irrazionale produzione di merci. Ciò servirà a legittimare investimenti pubblici per “trasformare” la produzione di beni e servizi in qualcosa di apparentemente diverso, ma che persegue la stessa finalità, ossia la crescita economica indefinita. La risposta verde è quindi un’altra forma del “capitalismo assistito”[2] ed in quest’ottica deve intendersi l’annuncio del vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis: un investimento di cento miliardi di euro all’anno per i prossimi dieci anni per la transizione verde. Ci tengono subito a sottolineare che i fondi sono disponibili per tutti, anche per quei paesi con minori problematiche legate alla decarbonizzazione: non è magnanimità ma l’impianto di un colossale investimento per riattivare le fornaci di un capitalismo che al momento è sorretto da iniezioni costanti di liquidità – quale il Quantitative Easing – che non riescono a rimettere in piedi il sistema. Dunque una sterzata verso il New Green Deal ed alla possibilità di aprire i rubinetti, riversando liquidità direttamente nella produzione. In barba, ovviamente a tutti i principi e dogmi del neoliberismo.
Come fare però per attuare il piano senza dover ammettere che il sistema è al collasso anche per colpa delle politiche made in Chicago? Beh la strategia è esattamente la stessa che ha imposto le purghe liberiste: la schock economy![3] Quindi si da ampio spazio alle sciagure e ai disastri, si bombarda il pubblico con dati – una volta tanto veri – riguardanti lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento della temperatura, si bacchetta la gente perché sporca, perché inquina, perché usa l’auto con il motore a combustione interna, perché tiene la luce accesa, ecc. si fanno sentire le persone colpevoli perché sono delle individualità eco-incompatibili, si riversa tutto su chi usa la tecnologia che era a disposizione fino a ieri, facendo finta che non vi sia chi la produce, ovviamente. Si terrorizza la gente a tal punto, che il fatto di regalare miliardi di euro a chi fino a ieri trafficava in petrolio e carbone o gestiva raffinerie e acciaierie vecchie di sessant’anni, non genera alcuna perplessità, anzi la gente è contenta se il costo dei disastri ambientali viene spalmato sul debito collettivo.
Rendere politicamente inevitabile ciò che sarebbe socialmente inaccettabile: questo è stato il meccanismo che ha spianato la strada alle privatizzazioni e questo è lo stesso mantra che ora apre la strada alla transizione del capitalismo verde. Un fenomeno da non dimenticare mai è quello della sussunzione capitalista: se l’argomento del giorno è il verde, il bio, l’ecocompatibile ecc. allora è inevitabile che ci siano delle polarizzazioni nel consumo di quei prodotti dalla “coscienza verde” – che poi di verde ci siano solo i dollari che se ne estrae è un altro paio di maniche ma tanto basta per giustificare un aumento dei prezzi al bancone del supermercato e per non giustificare affatto la stagnazione dei salari per i braccianti agricoli.
 Difatti il bombardamento di informazioni parla di coscienza ecologica, guardandosi però bene dal parlare di condizioni del lavoro: è un fatto che molte delle produzioni agricole bio, da destinare alla grande distribuzione negli USA, provenga dalla Imperial Valley, una “valle degli orti” dello zio Sam, esattamente davanti al varco di frontiera col Messico (di là dal confine c’è Mexicali, area desertica e povera della Baja California), un giardino che sperpera acqua, con un cancello d’ingresso su un altro Stato. Per superare certi “dettagli tecnici” e per indorare la pillola, si costruisce un messia del messaggio green, qualcuno dietro cui assieparsi e da seguire senza se e senza ma.
Difatti il bombardamento di informazioni parla di coscienza ecologica, guardandosi però bene dal parlare di condizioni del lavoro: è un fatto che molte delle produzioni agricole bio, da destinare alla grande distribuzione negli USA, provenga dalla Imperial Valley, una “valle degli orti” dello zio Sam, esattamente davanti al varco di frontiera col Messico (di là dal confine c’è Mexicali, area desertica e povera della Baja California), un giardino che sperpera acqua, con un cancello d’ingresso su un altro Stato. Per superare certi “dettagli tecnici” e per indorare la pillola, si costruisce un messia del messaggio green, qualcuno dietro cui assieparsi e da seguire senza se e senza ma.
Ora non si vuole qui tirare strali sulla persona di Greta Thunberg, ma su ciò che il personaggio in sé rappresenta in un’ottica di sussunzione capitalista da un lato e di elemento funzionale alla shock economy dall’altro. È un fatto che il pensiero circa la responsabilità individuale e collettiva che fa eco negli scritti e negli interventi della Thunberg, derivi anche dal patrimonio di anni di lotte e sensibilizzazioni da parte di attivisti e pensatori radicali, da Barry Horne a Murray Bookchin, i quali sono rimasti grandemente inascoltati. Avevano due “gravi colpe”, dire queste cose negli anni dell’espansione capitalista – anni ’60-’70 – ed essere militanti anarchici. Quindi difficilmente il meccanismo della sussunzione capitalista avrebbe potuto attecchire su queste forme pensiero e difficilmente si sarebbero visti parlare ad una conferenza sul clima. Invece la figura di una giovane ragazza, che cerca di convincere il suo governo, è molto più spendibile del Baffuto Murray o del combattivo Barry.
Gli stessi interventi della Thunberg se letti integralmente rimandano, almeno in quanto a suggestioni ed in forma abbozzata, ad una qualche forma di critica alle strutture della società stessa. Quindi ci troviamo davanti ad un apparente cambio epocale che però arriva dalla parte sbagliata del meccanismo, arriva dalla testa, come accettazione ed acclamazione di alcune istanze necessarie per rinnovare la meccanica della riproduzione del capitale. Da qualunque punto arrivi ci sono però dei concetti che rappresentano sempre un punto debole del sistema e su quelli bisognerebbe insistere mettendone a nudo le contraddizioni.
Questo non vuol dire però cavalcare, ad esempio, in maniera predatoria i movimenti giovanili dei Friday For Future o demolire per puro istinto polemico la figura della Thunberg. Vuol dire invece cercare i punti critici della narrazione della svolta verde, portare alla luce le contraddizioni facendo leva su quelle parole che hanno catturato per un attimo l’attenzione e decostruirle, non in una contro-narrazione, ma in pratiche articolate per raggiungere l’incompatibilità piena e matura con il sistema di riproduzione capitalista. Ricordare che gli investimenti pubblici sulla svolta verde sono donazioni ad un comparto industriale vetusto, che non vanno nella direzione delle bonifiche dei territori o della generale messa in sicurezza delle zone a rischio di dissesto idro-geologico: questi investimenti non mettono in discussione grandi opere inutili o logiche di aggressione del territorio attraverso il ricatto dei mercati. Come diceva Chico Mendes, ambientalista brasiliano ucciso per il suo impegno nella difesa dell’ambiente dalla deforestazione, “L’ambientalismo senza lotta di classe è semplicemente giardinaggio”, creare isole felici in un paesaggio desolato dal punto di vista socio-ambientale, non è una strategia per salvare tutti ma per permettere a qualcuno di sopravvivere nell’attesa dell’inevitabile.
Il mascherare in verde le politiche degli stati non significa assolutamente giungere a una qualche forma di incompatibilità. Anzi: la “svolta verde” non serve solamente a tentare di fare ripartire la macchina della produzione e dell’accumulazione capitalista, tramite un qualche Green New Deal, ma serve anche a creare un discorso pubblico che permetta di ricreare una forma di coesione sociale, dopo che questa si è grandemente degradata a causa della costante erosione del tessuto sociale negli anni dell’austerity.
Certi settori della società, sopratutto quelli della sinistra riformista, sono sicuramente sensibili al messaggio del Green New Deal. Le sirene del capitalismo verde attirano coloro che sono mossi dalla buona volontà di “migliorare la società”. È l’eterno ritorno della falsa coscienza, del vecchio mondo che non vuole morire. Il capitalismo e le strutture gerarchiche nel loro movimento di sussunzione del mondo alla logica della merce e della gerarchia necessitano di questa svolta per tentare di ridare una qualche forma di ordine al caos che le politiche di austerity e quaranta anni di neoliberismo ha generato.
Al contempo anche i settore più autenticamente reazionari e di destra riorganizzano il loro discorso intorno a queste tematiche. Non è una novità che gli ambienti dell’ambientalismo, del conservazionismo ambientale, della deep ecology, siano non solo da sempre permeabili alla presenza di elementi di derivazione fascista ma che la loro stessa base teorica sia profondamente legata a quell’ambientalismo Volkshik novecentesco.
Riemerge con forza il discorso della sovrappopolazione e del controllo delle nascite non come libera autogestione individuale – e collettiva – ma come gerarchia razzializzata e classista. Si punta il dito contro i tassi di natalità nei paesi non occidentali – o meglio con un economia sufficientemente sviluppata tale da porli al centro o vicino al centro del sistema-mondo – e si additano le masse di proletari di inurbazione recente o piccoli contadini dei paesi periferici, come colpevoli della crisi ecologica.
Il migrante, sempre più spesso migrante climatico prima ancora che “migrante economico”, diviene quindi nemico non solo in quanto elemento allogeno ma in quanto portatore di rischi ambientali. Coloro che hanno maggiormente subito sulle loro pelle l’imponente ristrutturazione dello spazio geografico ai fini dell’accumulazione di capitale avvenuta con il processo di integrazione globale – la così detta globalizzazione – divengono quindi nemici.
Le frontiere vanno difese per difendere la nostra cultura e il nostro ambiente. Poco importa che i responsabili della crisi ecologica vivano in un appartamento di lusso a Manhattan o nella City londinese, in un attico di Shangai o Singapore, si muovano su jet privati dal forte impatto ambientale, consumino centinaia di miglia di litri d’acqua per tenere verde un campo da golf sorto in un ambiente che non lo permetterebbe. Poco importa che intere città siano sorte dove le condizioni ambientali meno lo consigliavano – si pensi a Las Vegas od alla stessa area periurbana di Los Angeles negli USA od alle megalopoli asiatiche sorte ai fini di concentrare la popolazione e favorire l’accumulazione di capitale – la colpa va riversata sugli ultimi. La risposta reazionaria, l’ecofascismo, e la risposta socialdemocratica, il Green New Deal, possono andare di pari passo. Ambiente pulito per i ricchi e per una classe media che è da ricostruire da capo e muri, filo spinato, frontiere, ambienti insalubri e inquinati o inondati dall’innalzamento dei mari per gli sfruttati.
L’intersezione tra le diverse forme di oppressione diviene evidente quando si parla di ecologia. Si pensi a come le discariche di rifiuti tossici negli USA vengano costruite, guarda caso, a ridosso delle aree abitate dalla popolazione afroamericana o indigena. O di come, in Italia, queste siano state costruite all’inizio, o meglio scavate al di fuori di qualsiasi controllo, in aree economicamente depresse del meridione.
L’ecologia sociale degli anarchici si distingue per saper tenere insieme le forme di lotta a queste particolari oppressioni e saperle integrare in ottica intersezionale tra di loro. La chiave di volta non è l’aggiustamento o la riforma strutturale, il tinteggiare di verde, ma è la radicale critica del mondo.
Lorcon e J.R.
NOTE
[1] Cfr. SPENCE, Michael, “The Impact of Globalization on Income and Employment: the Downside of Integrating Markets.”. in Foreign Affairs, 90, 2011.
[2] Cfr. PICCIONI, Francesco, “La Guerra Finanziaria del “Capitalismo Verde”, in Contropiano, 23 Settembre 2019, http://contropiano.org/news/news-economia/2019/09/23/la-guerra-finanziaria-del-capitalismo-verde-0118957
[3] Cfr. KLEIN, Naomy, Shock Economy”: l’Ascesa del Capitalismo dei Disastri, Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 2007.