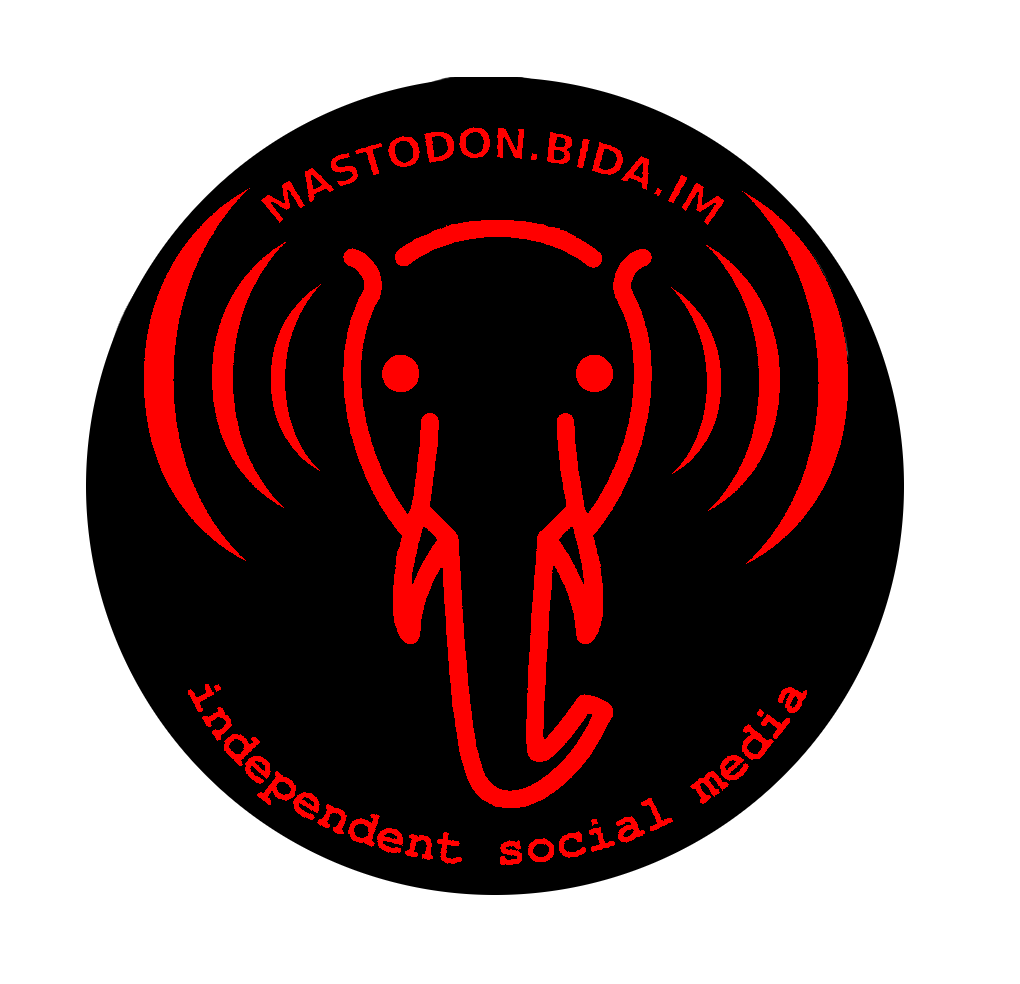Il seguente articolo è stato pubblicato su Umanità Nova numero 27 anno 99
 La crisi ecologica che stiamo vivendo globalmente è il prodotto diretto del capitalismo: un modo di produzione basato non sul soddisfacimento dei bisogni di individui e comunità ma sullo sfruttamento del lavoro dei più e sulla distruzione delle risorse naturali per il profitto della classe dominante.
La crisi ecologica che stiamo vivendo globalmente è il prodotto diretto del capitalismo: un modo di produzione basato non sul soddisfacimento dei bisogni di individui e comunità ma sullo sfruttamento del lavoro dei più e sulla distruzione delle risorse naturali per il profitto della classe dominante.
Il capitalismo si basa sulla trasformazione di qualsiasi risorsa e del lavoro umano in merce, il cui valore di scambio è slegato dal valore d’uso. La produzione di merce non segue nessuna razionalità se non quella interna alla logica del capitale. Pensiamo, ad esempio, al settore tessile, uno dei settori che è stato alla base dell’accumulazione capitalista fin dal tardo medioevo: non si privilegia la creazione di capi duraturi ma una sovrabbondanza di capi di pessima qualità, con filiere lunghissime – materie prime e centri di produzione dislocati in diverse aree del pianeta e semilavorati e lavorati spostati tramite reti logistiche globali – che durano poco e soggetti, per altro, ai cicli delle mode. O all’elettronica di consumo, dagli elettrodomestici ai computer e smartphone, in cui l’obsolescenza programmata e il rendere difficoltose le riparazioni – non facendo reperire i pezzi di ricambio o incollando la componentistica al posto di usare meccanismi di chiusura a vite o incastro – sono la norma.
Ma allarghiamo l’orizzonte: la produzione energetica globale, fonte di pesanti devastazioni ambientali nei siti dove si estraggono le materie prime fossili e che per questo andrebbe razionalizzata fortemente, finisce per alimentare produzioni sovrabbondanti e inutili, anche grazie al legame tra materie fossili e materie plastiche di cui spesso si potrebbe fare a meno. E le plastiche hanno conseguenze ambientali pesantissime anche quando vengono riciclate dato che spezzare le catene polimeriche, decolorare, frantumare e riassemblare sono operazioni energeticamente costose. Eppure in un sistema in cui si deve alimentare il vulcano della produzione, che ciclicamente andrà ad impantanarsi nella palude del mercato, queste materie sono ovunque: costano meno rispetto ad altre, garantiscono maggiore profitto. [1]
L’origine della crisi ecologica non è da ricercarsi nei consumi ma nella produzione, ovvero nel capitalismo di cui il consumismo è solo un corollario: è l’offerta che determina la domanda. La critica dei consumi va sostituita con la critica della produzione, pena la caduta nel circolo vizioso del moralismo, della colpevolizzandone dell’individuo e dell’assoluzione del sistema che soggiace a produzioni nocive e irrazionali. Certo, ad esempio, noi tutti potremmo utilizzare borracce di alluminio in luogo delle bottigliette di plastica, e c’è chi lo fa da tempi non sospetti, ma se poi mancano le fontanelle pubbliche, spesso eliminate in nome di politiche contro il “degrado urbano”, per riempirle? E sei nei bar si rifiutano di farmi rifornimento? Forse sarebbe il caso di pensare che il problema non è tanto chi si trova a dovere comprare bottigliette di plastica ma il fatto che le aziende che vendono acqua imbottigliata in realtà vendono bottiglie di plastica. Altro esempio: fonte di inquinamento massiccio nelle aree urbanizzate sono i sistemi di riscaldamento poco efficienti. Bisognerebbe sostituire con nuovi sistemi le vecchie caldaie condominiali e attuare coibentazioni degli ambienti, ma in un quartiere popolare chi ha i soldi per fare queste migliorie? Come si può pretendere che persone a basso reddito, già costrette a comprare un appartamento in seguito all’alienazione del patrimonio immobiliare degli istituti per le case popolari, investano parte consistente dello stesso per fare realizzare un cappotto al loro stabile quando, magari, hanno difficoltà a pagare le normali bollette.
Dopo decenni di inazione da parte dei governi, ovvero dei comitati esecutivi della classe dominante, un movimento globale sorge e chiede “risposte concrete” su questi temi. Ma è un movimento che finora non ha avuto modo di legarsi e amalgamarsi con un più generale movimento per l’emancipazione sociale, chiede a chi ha generato il problema di risolvere. Ma per risolvere questo problema il capitalismo dovrebbe autoestinguersi, e non ci pare che la classe dominante abbia in agenda la propria stessa abolizione.
Si prova a costruire un discorso, un regime di verità, basato su una concezione pauperistica della vita, che leghi la risposta alla crisi ambientale, che deve essere rigorosamente individuale, monadica, e non collettiva, a misure di austerity che permettano di conservare a ampliare i profitti della classe dominante. La loro scommessa è fare introiettare l’austerity e il pauperismo come elementi morali e valori fondamentali per la vita associata, senza toccare il nodo delle industrie inquinanti, responsabili della gran parte delle emissioni di gas serra, scaricando, al solito, la colpa sulla classe dominata, cornuta e mazziata. I proletari non possono permettersi il cibo biologico e prodotto nel “rispetto dell’ambiente” di NaturaSì, vanno a fare la spesa al Lidl, o quando va bene in un normale supermercato di una qualche catena della GDO. Non possono permettersi auto elettriche o ibride e al contempo devono fare fronte a una cronica e strutturale mancanza di trasporti pubblici e devono usare macchine Euro2 o Euro3 per recarsi sul luogo di lavoro, a volte distante decine di kilometri. Ma questo i fautori del pauperismo fanno finta di ignorarlo, altrimenti si dovrebbe mettere in discussione la presenza di lavori assolutamente irrazionali e inutili, sia nel manifatturiero che nei servizi, eppure energivori sia in termini di produzione che in termini di energie spese per recarsi sui luoghi di lavori stessi.
L’ideologia della classe dominante fa di tutto per presentarsi come scientifica, ragionevole e razionale quando in realtà è semplice ragione strumentale e logica con assiomi assunti come precetti religiosi.
La green economy che provano a spacciare per salvezza non intacca minimamente i problemi strutturali del sistema sociale in cui viviamo. Ai fini dell’emancipazione umana e di un armonico rapporto con l’ecosistema in cui l’umanità vive poco cambia che si distrugga il Delta del Niger a furia di trivellazioni petrolifere o gli altipiani dell’America Latina per estrarre litio per le batterie di costosissime auto sportive Tesla. Distruggere le colture a uso alimentare per ricavare biomassa o biodiesel non è differente rispetto a distruggere i territori estraendo greggio.
La classe dominante ha intuito che movimenti come Fridays for Futures e Extinction Rebellion possono diventare qualcosa di più di semplici presentazioni di desiderata ai governi o, alla peggio di un qualche parziale ricambio nella classe dirigente. Per questo ha la necessità di ingabbiarla, cooptarla, disinnescarla. Ecco spiegato perché la politica politicante fa a gara per esprimere vicinanza ai giovani che scendono in piazza – certamente oltre a questo vi è anche il tentativo di cercarsi nuovi e giovani elettori in una fascia demografica piuttosto disincantata rispetto ai richiami delle urne – ha intuito i pericoli, ha bisogno riassorbire queste energie che potrebbero prendere altre strade.
Lo sviluppo del discorso ecologico porta al riconoscere un’intersezionalità del dominio e la necessità di un’intersezionalità delle lotte sociali. E di questo la classe dominante ha paura. La devastazione ambientale si collega a dinamiche legate al dominio di classe ma anche a quelle della razzializzazione e della divisione per generi. Se negli Stati Uniti, ad esempio, deve essere costruita una nuova discarica per rifiuti tossici o impiantata un’industria nociva questo verrà fatto in una zona in cui vi è una maggioranza di popolazione di colore o vicino a una riserva indiana. Le dinamiche del land grabbing nei paesi in via di sviluppo incidono fortemente sull’autonomia femminile, come ben spiegato da Silvia Federici nella sua raccolta di saggi “Reincantare il mondo”[2]. Il dominio passa da diversi vettori, chi vuole resistere alla devastazione sociale e ambientale e costruire qui e ora un mondo radicalmente altro non può non tenerne conto.
Un altro aspetto non secondario è che la crisi ambientale offre nuove possibilità di accumulazione capitalista. Banalmente l’innalzamento delle temperature marine – e gli oceani sono gli ecosistemi che più stanno raccogliendo calore e più risentono del global warming – permette l’apertura di nuove rotte commerciali a nord, nel Circolo Polare Artico, permettendo di ridurre drasticamente i tempi di navigazione tra Asia e Europa ed evitare il potenzialmente instabile canale di Suez o gli stretti del sud-est asiatico. Offre, sopratutto, migliori possibilità di sfruttamento dei giacimenti fossili e minerari in Siberia, nei mari dello stesso Circolo Polare, che potrebbero permettere, ad esempio, a potenze come Cina e Stati Uniti di rendersi energeticamente indipendenti sia dall’importazione di idrocarburi dal medio-oriente che da sistemi eccessivamente costosi di estrazione delle risorse fossili come il fracking.
E, inoltre, vi è tutto il mercato finanziario legato ai disastri naturali: assicurazioni per eventi climatici estremi, con relativo mercato di riassicurazioni, obbligazioni-catastrofe, bond ambientali, mercato delle quote di CO2.
Non basta ridurre i consumi individuali per porre freno alla crisi ecosistemica, bisogna agire alla radice del problema. Non servono maggiori o minori soluzioni tecniche, come quelle offerte da presunti “Green New Deal” o da soluzioni di decrescita (in)felice. E non si può dimenticare l’enorme impatto ambientale degli apparati militari, attualmente tra i più grandi inquinatori al mondo [3].
I piani per un Green New Deal sono fallimentari per loro stessa natura così come è stato fallimentare il vecchio New Deal degli anni che furono, collassato dopo pochi decenni sotto le sue stesse contraddizioni e la volontà della classe dominante di aumentare il suo profitto dopo essere stato costretto dai movimenti sociali a cederne una quota tramite il salario differito delle politiche welfaristiche. Lungo il corso del novecento le soluzioni riformiste, cioè che avevano la pretesa di cambiare solo alcuni aspetti del sistema economico senza intaccare le radici dei problemi, hanno dimostrato i loro limiti e sono, infine, tramontate.
La nostra scommessa è quella di una società basata sull’autogestione delle nostre vite, sulla produzione di beni – non di merci – che permettano di soddisfare i bisogni di tutti e tutte, di costruire una vita che vada oltre la mera sopravvivenza.
La razionalizzazione della produzione per evitare gli sprechi non è possibile con una società che si basa sullo squilibrio economico e di potere. Una produzione orientata verso il soddisfacimento dei bisogni e non verso l’accumulazione di capitale è possibile solamente in una società autogestita che abolisca fin da subito i privilegi e le differenze di classe, razza genere e specie, che abolisca il lavoro salariato e lo stato.
I limiti di movimenti come Friday For Future sono evidenti ma questi movimenti dimostrano al contempo che esiste un malcontento di fondo da parte di moltissimi giovani, che si vedono ora non solo negato un futuro dignitoso, , anche se interno alle compatibilità sistemiche, per quanto riguarda la condizione economica ma anche, e sempre più, per quanto riguarda le stesse condizioni ambientali.
Lorcon
[1] si veda anche l’articolo “Energia e rivoluzione industriale”: https://umanitanova.org/?p=3039 presente anche su questo blog
[2] Federici, Silvia “Reincantare il Mondo”, Ombre Corte, 2018
[3] Keucheyan, Razmig “La natura è un campo di battaglia. Saggio di ecologia politica”, Ombre Corte, 2019