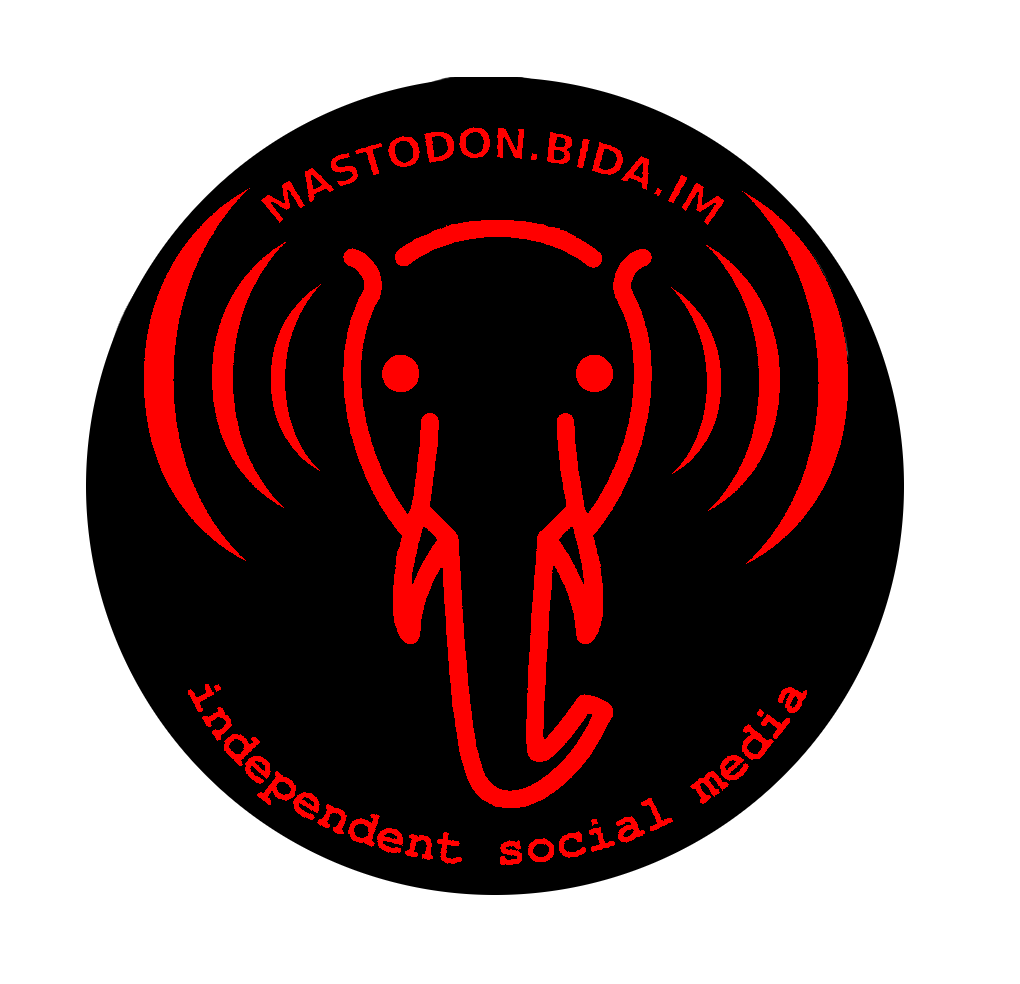Il seguente articolo verrà pubblicato su Umanità Nova numero 29 anno 99
 Un anno e mezzo dopo l’offensiva che ha portato all’occupazione di Afrin, occupazione che ha visto per l’altro il sorgere ed il dispiegarsi di una forte guerriglia di opposizione, lo stato turco cerca di chiudere una volta per tutte la partita in Rojava.
Un anno e mezzo dopo l’offensiva che ha portato all’occupazione di Afrin, occupazione che ha visto per l’altro il sorgere ed il dispiegarsi di una forte guerriglia di opposizione, lo stato turco cerca di chiudere una volta per tutte la partita in Rojava.
Dopo mesi di preparazione e subito dopo l’annuncio del presidente statunitense Trump circa il ridislocamento delle forze del Pentagono presenti nell’area, l’aviazione e l’artiglieria turca hanno iniziato i bombardamenti dei villaggi e delle città nel Rojava mentre colonne corazzate sono penetrate di circa cinque chilometri nel territorio curdo-siriano sotto il controllo del PYD e delle SDF.
Contemporaneamente milizie islamiste non ufficialmente legate allo stato Turco, quindi più libere di compiere massacri ed al contempo maggiormente sacrificabili, hanno fatto il lavoro sporco fornendo la forza d’urto sul fronte e compiendo attacchi nelle retrovie.
L’azione dello stato turco non era più rimandabile nella logica di Erdogan. La pluriennale crisi economica che ha molato i denti della tigre anatolica rischia di trasformarsi in recessione conclamata, soprattutto se gli attriti sempre più forti nel Golfo Persico portassero a un’impennata nel prezzo del greggio. Anni di guerra civile in Bakur, dove per altro l’insurrezione non si è ancora placata, non hanno aiutato anche se il blocco di affaristi del cemento che sostiene Erdogan sta facendo affari con la ricostruzione delle città, in molti casi vere e proprie operazioni di ingegneria demografica.
Il ricorso al nemico esterno è sicuramente un buon diversivo per la pubblica opinione e probabilmente c’è chi spera che funga da volano per l’economia, il settore militare divora un 2% abbondante del PIL – anche se siamo lontani dal 4,5% degli anni novanta non è poco – le commesse militari fanno gola e sono sempre buona occasione per arricchirsi per la borghesia anatolica.
Il progetto neo-ottomano di Erdogan consiste nel creare un corridoio a sud, penetrando in Siria, scalzando Assad e la sua cricca rafforzando, nel contempo, la propria presenza nel Caucaso e nelle aree musulmane dei Balcani dove proporsi come protettore nell’eventualità di eventuali rigurgiti sciovinisti serbo-croati, tutto ciò aumentando la propria capacità di proiezione nel Mediterraneo, è in stallo da anni.
I rovesci della guerra civile siriana, il crollo dello Stato Islamico, la tenuta del regime di Assad e la necessità di trovare una forma di collaborazione con la Russia putiniana dopo il pericoloso deteriorarsi delle relazioni bilaterali tra i due paesi, hanno portato la Turchia in una posizione isolata.
 Contemporaneamente all’assedio di Kobane da parte dell’ISIS, finanziato e sostenuto a tutti i livelli dalla Turchia, anche tramite l’acquisto di enormi quantità di petrolio di contrabbando e la fornitura diretta di materiale bellico, intelligence ed approvvigionamenti, vi è stata l’insurrezione del Bakur. Un’insurrezione che nei suoi risultati immediati è stata vittoriosa: ha costretto il governo turco ad aprire la frontiera ai profughi curdo-siriani, alleggerendo la situazione umanitaria in Rojava ed a fare transitare gli aiuti militari internazionali verso Kobane. Uno smacco enorme per Erdogan. I sogni della borghesia di Ankara di porsi come paese egemone a livello sovra regionale sono stati frustrati. Con questa operazione Erdogan probabilmente si gioca il tutto per tutto.
Contemporaneamente all’assedio di Kobane da parte dell’ISIS, finanziato e sostenuto a tutti i livelli dalla Turchia, anche tramite l’acquisto di enormi quantità di petrolio di contrabbando e la fornitura diretta di materiale bellico, intelligence ed approvvigionamenti, vi è stata l’insurrezione del Bakur. Un’insurrezione che nei suoi risultati immediati è stata vittoriosa: ha costretto il governo turco ad aprire la frontiera ai profughi curdo-siriani, alleggerendo la situazione umanitaria in Rojava ed a fare transitare gli aiuti militari internazionali verso Kobane. Uno smacco enorme per Erdogan. I sogni della borghesia di Ankara di porsi come paese egemone a livello sovra regionale sono stati frustrati. Con questa operazione Erdogan probabilmente si gioca il tutto per tutto.
Se, come auspicabile, la forza armata turca fallirà nell’operazione lampo che dovrebbe permettere di respingere permanentemente di almeno quaranta-cinquanta chilometri le forze dell’SDF dalla frontiera, il governo di Erdogan rischierà di trovarsi impantanato in un Vietnam (o in un Afghanistan) in salsa siriana.
Di fronte ad una crisi economica difficilmente contenibile e con la spada di Damocle di un’imminente impennata dei prezzi delle commodities energetiche, per l’aggravarsi della crisi nella faglia del Golfo, sostenere il peso di una guerra di logoramento potrebbe innescare una pesante crisi interna. La piccola borghesia che fino a ora ha sostenuto l’AKP potrebbe rivoltarsi e le stesse forze armate potrebbero, nonostante le pesanti purghe degli ultimi anni, dimostrarsi meno collaborative del dovuto.
Erdogan ha sì un forte consenso interno ma è un consenso polarizzato: milioni di turchi lo votano ma altri milioni lo vorrebbero vedere volentieri scomparire dalla scena politica e non pochi lo espellerebbero volentieri dal consorzio umano. La politica di appeasement verso la Russia, che è stata una scelta obbligata per non aprire uno scomodo fronte diplomatico contro Mosca – ma anche militare vista la posizione del governo di Putin sulla questione siriana – ha portato a un deterioramento delle relazioni con l’asse atlantico. Lo stesso Israele, da decenni vicino diplomaticamente e militarmente alla Turchia, vede con sempre meno simpatia il governo di Ankara.
Erdogan è un giocatore d’azzardo: quando è in difficoltà rilancia. Ma il suo è un gioco pericoloso, un giocatore con una migliore mano di carte potrebbe decidere di vedere e il bluff a quel punto sarebbe palese. C’è chi vedrebbe volentieri la Turchia impantanata nel Rojava e potrebbe decidere che fornire supporto di intelligence e di forniture militari – ovviamente sottobanco – al PYD e alle SDF sarebbe una buona mossa. Sicuramente Damasco vuole recuperare a sé le aree curdo-siriane. In cambio di un alleggerimento delle richieste di autonomia dal governo centrale potrebbe agire effettivamente come protettore di un territorio su cui teoricamente avrebbe la sovranità. A quel punto per Ankara la partita si complicherebbe sul piano militare.
Potrebbe perdere ma paradossalmente vincere: sconfitta sul campo da un non sostenibile sforzo bellico ma vittoriosa nel fine di impedire la realizzazione di un territorio autonomo curdo. Ma sarebbe, a ogni modo, una sconfitta per Ankara – se vince il nemico del tuo nemico non vinci automaticamente tu – come lo sarebbe per il PYD e il suo progetto di una Siria secolarista, democratica e federalista: Damasco ne risulterebbe il vero vincitore. Insieme a Teheran che, pur condannando l’aggressione turca, vede come fumo negli occhi l’autonomia del Rojava che intrattiene fraterni rapporti con il PJAK, il ramo iraniano dell’indipendentismo curdo, che ha fatto sue le teorie apociste. Il progetto del Confederalismo Democratico, in ogni modo, non ne uscirà indenne, come non è uscito indenne dalle prove che ha dovuto affrontare in questi anni.
L’insorgenza siriana del 2012, che è coeva alle altre primavere arabe, ha le sue origini in un decennio di smantellamento in senso neoliberale delle strutture pubbliche che, fornendo aiuti materiali alle classi popolari sotto forma di sussidi economici o distribuzione diretta di beni di prima necessità – cibo ed acqua, principalmente – sancivano il patto sociale che era in vigore dagli anni ’60, cioè quando i governi impiantanti dalle ex potenze coloniali erano stati spazzati via dai colpi di stato militari – ma di militari modernisti – in Siria ed Egitto. Crollato il patto sociale socialnazionalista – ed in certi momenti panarabo – le forze centrifughe hanno prevalso: la questione di classe, largamente nascosta anche in molte analisi fatte da sinistra, è esplosa al pari della questione delle varie identità culturali che sono state schiacciate sotto progetti di arabizzazione forzata: vi è il problema, questo tipicamente siriano, del rapporto tra alauiti e sunniti, con la complicazione del rapporto tra alauiti e sciiti, i quali hanno riconosciuti gli alauiti come musulmani esclusivamente per ragioni politiche.
L’insorgenza siriana è nata sulle parole d’ordine di una società maggiormente libera e con meno divario sociale ed è finita schiacciata sotto il martello della repressione militare di Damasco. La reazione islamista ha avuto gioco facile nell’imporsi come principale opposizione ad Assad che, per altro, preferiva grandemente avere come nemico principale degli impresentabili tagliagole islamisti che partiti ed organizzazioni laiche e di sinistra. Così facendo si è riciclato come baluardo contro l’islamismo sunnita e si è garantito una continuità nel potere che non sarebbe stata altrimenti scontata. Le organizzazioni curdo-siriane in quella situazione hanno pensato di poter fare il loro gioco tirandosi fuori per alcuni anni dalla mischia con un accordo di non belligeranza con il regime di Damasco – che è il motivo per cui quello che rimane dell’opposizione laica e di sinistra ad Assad non vede con simpatia le istanze portate avanti in Rojava – per ricavarsi lo spazio geografico per l’esperimento di Confederalismo Democratico.
 Progetto molto interessante sulla carta ma viziato nella pratica da diversi problemi, alcuni imputabili a quello che è stato un errore strategico dettato dall’opportunità – il patto di non belligeranza con il regime che ha portato alla forte ostilità di altre componenti dell’insorgenza – altri dovuti dal fatto che l’attacco del 2014 da parte dello Stato Islamico ha costretto ad un’innaturale alleanza con delle forze imperialiste che seguivano le loro agende e che hanno usato i curdi siriani come fanteria legandoli a sé. Non che il PYD non se ne rendesse conto ma oramai era in ballo e doveva ballare. Ora si trova tra il martello dell’aggressione turca e l’incudine del dovere probabilmente accettare un accordo svantaggioso con il governo di Damasco che nel frattempo ha recuperato, grazie a russi e iraniani, molto terreno.
Progetto molto interessante sulla carta ma viziato nella pratica da diversi problemi, alcuni imputabili a quello che è stato un errore strategico dettato dall’opportunità – il patto di non belligeranza con il regime che ha portato alla forte ostilità di altre componenti dell’insorgenza – altri dovuti dal fatto che l’attacco del 2014 da parte dello Stato Islamico ha costretto ad un’innaturale alleanza con delle forze imperialiste che seguivano le loro agende e che hanno usato i curdi siriani come fanteria legandoli a sé. Non che il PYD non se ne rendesse conto ma oramai era in ballo e doveva ballare. Ora si trova tra il martello dell’aggressione turca e l’incudine del dovere probabilmente accettare un accordo svantaggioso con il governo di Damasco che nel frattempo ha recuperato, grazie a russi e iraniani, molto terreno.
Il riflusso dell’insorgenza Turca di Gezi Park, la pesante repressione in Bakur, la mancata saldatura tra l’insorgenza sociale urbana di Istanbul e la questione di classe nei centri minori dell’Anatolia, dove pure il proletariato impegnato in settori come quello minerario, edile e manifatturiero ha dato prova di una certa combattività, il tentativo di colpo di stato dei generali del luglio 2016 che ha rafforzato il potere dell’AKP, tutti questi fattori hanno contribuito a rendere difficilmente attuabile l’estensione del modello democratico-confederalista nel Bakur, che sarebbe stata la garanzia per la tenuta del progetto. La scommessa dell’HDP di poter giocare pulito per via elettorale nel Bakur è stata persa: rafforzatosi il potere dell’AKP i sindaci delle municipalità controllate dall’HDP sono stati rimossi, perseguitati e arrestati.
Il progetto stesso del confederalismo democratico paga le conseguenze di alcuni problemi di fondo: un’organizzazione sociale che, se pur estremamente avanzata, non affronta compiutamente la questione di classe nei territori dove è riuscita vittoriosa, le circostanze della sua nascita stessa, ovvero la non belligeranza con il regime di Damasco nel momento in cui questo stava per collassare, il residuale etnicismo curdo, l’essersi dovuto legare obtorto collo all’agenda imperialista statunitense e in certi periodi russa in Siria.
La guerra contro i tagliagole islamisti dell’ISIS ha costretto il PYD e le SDF a porsi sotto l’ombrello di questa o quella compagine imperialista agendo anche fuori dei territori in cui il progetto democratico-confederalista era nato e aveva il supporto di massa. La battaglia di Raqqa che ha visto il tramonto del dominio territoriale dello Stato Islamico, che da Stato in pectore è tornato ad essere una compagine senza terra, ha visto pagare un prezzo altissimo alla popolazione di Raqqa. La narrazione epica non regge al confronto con la materialità. I bombardamenti da parte della Coalizione Internazionale su Raqqa hanno causato un’enorme numero di morti tra la popolazione civile, la stessa popolazione che veniva schiacciata sotto il dominio islamista è stata bombardata per mesi dall’aviazione della Coalizione. Allo stesso identico modo in cui i quartieri operai di Amburgo, Colonia, Torino, Milano e Roma venivano bombardati dall’aviazione Alleata durante il secondo conflitto mondiale.
Il paragone non è casuale: i conflitti inter-imperialistici vedono pagare il più alto prezzo da parte dei proletari stessi. Le narrazioni affabulatorie possono fornire giustificazioni a posteriori ma vanno dissezionate. La superficie va divelta e bisogna guardare nell’abisso che si apre al di sotto di essa. La coerenza del programma rivoluzionario non permette cedimenti, non fornisce scuse per tatticismi. La logica del male minore la lasciamo volentieri alla retorica di “danni collaterali” cara al gioco al massacro delle guerre umanitarie. La tattica deve essere subordinata alla strategia.
La sperimentazione del modello del confederalismo democratico in Rojava ha dato importanti risultati. Ha permesso di infliggere pesanti colpi alla società patriarcale in quelle terre, ha aperto spiragli nella cappa di piombo degli stati-nazione. Ha aperto una sfida importate. Ha impostato un’economia di stampo cooperativistico, un risultato intermedio comunque non indifferente. Ha messo in crisi profonda il monopolio della violenza caro ai sovranisti, non a caso tutti innamorati di Assad e della sua cricca di criminali. Si è scontrato però contro i limiti dati da rivoluzioni appena abbozzate e fallite in Siria e Turchia e con il tatticismo della non belligeranza verso Damasco prima e del legame troppo stretto con le agende delle classi dominanti statunitensi e russe. Tatticismi di certo non desiderati ed imposti ma che hanno minato il progetto. La situazione di guerra ha minato il processo di avanzamento sociale, fermare la guerra significa riaprire uno spiraglio che dia spazio all’azione di quanti si muovono verso la costruzione di una società altra. La guerra contro lo Stato Islamico e contro lo stato turco ha fatto cadere sul campo migliaia di compagni, tra cui decine di volontari internazionali accorsi per partecipare a un progetto che, pur con i limiti e le contraddizioni che abbiamo evidenziato, ha rappresentato un importante passo nella direzione della costruzione di una società radicalmente avversa al mondo vigente. Passi parziali e in certi momenti incerti, passi che si sono mossi in un contesto irto di pericoli ma, comunque, un generoso tentativo che ha rilanciato la scommessa contro lo stato e il capitale.
Ora che i venti di guerra si rafforzano – di certo non hanno mai smesso di soffiare – sul Rojava è necessario creare un’ampia mobilitazione internazionale dal basso che metta i bastoni tra le ruote dell’invasione da parte dello stato turco. Coloro che sono nella posizione per bloccare i piani criminali di Ankara sono gli stessi proletari turchi che potrebbero porre fine al gioco al massacro, che ricadrà su loro stessi dato che di certo non sono le famiglie dell’oligarchia dell’AKP a fornire i soldati che moriranno, abbattendo il regime di Erdogan. L’esempio della Prima Guerra Mondiale ha mostrato, in Germania come in Russia, che il disfattismo rivoluzionario, l’ammutinamento, la diserzione, lo sciopero possono attivamente fermare massacri che i governi vogliono portare avanti per conto dei loro mandanti.
La Turchia è un paese NATO e le sue forze armate sono integrate nel sistema militare atlantico. L’Italia è uno uno dei maggiori fornitori di tecnologie belliche per il paese anatolico – si pensi agli elicotteri Mangusta – dunque le fabbriche di questi sistemi d’arma si trovano sul territorio italiano. Rilanciare la mobilitazione antimilitarista in Italia, come in tutti i paesi, significa aiutare concretamente chi si trova a combattere sul campo il tentativo di genocidio messo in atto da Ankara. Quest’anno si terrà, a Torino, il biennale European Defence Meeting, la fiera di settore – rigorosamente aperta solo ad appartenenti a chi agisce nel campo bellico – e questa può essere una buona occasione di mobilitazione, che sta già venendo organizzata. Anche lo sciopero generale del sindacalismo di base del 25 ottobre deve diventare occasione di rilancio della mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici contro le politiche di guerra.
La guerra, con i suoi cicli di distruzione e creazione di merce, è centrale per il processo di accumulazione capitalista, denunciare questo fattore è fondamentale per la nostra azione.
La linea di faglia del Golfo è sempre più tesa, il rischio di una conflagrazione sovra-regionale è dietro l’angolo. Il prezzo della guerra lo pagheranno i proletari di tutto il mondo. Alcuni lo pagheranno venendo massacrati in guerra, altri lo pagheranno con una riedizione della crisi petrolifera. Come è sempre stato e come sempre sarà fintanto che non verranno smantellate le fondamenta stesse di un’organizzazione sociale basata sull’accumulazione di capitale, sul dominio, sul patriarcato, sugli stati.
Lorcon e J.R.