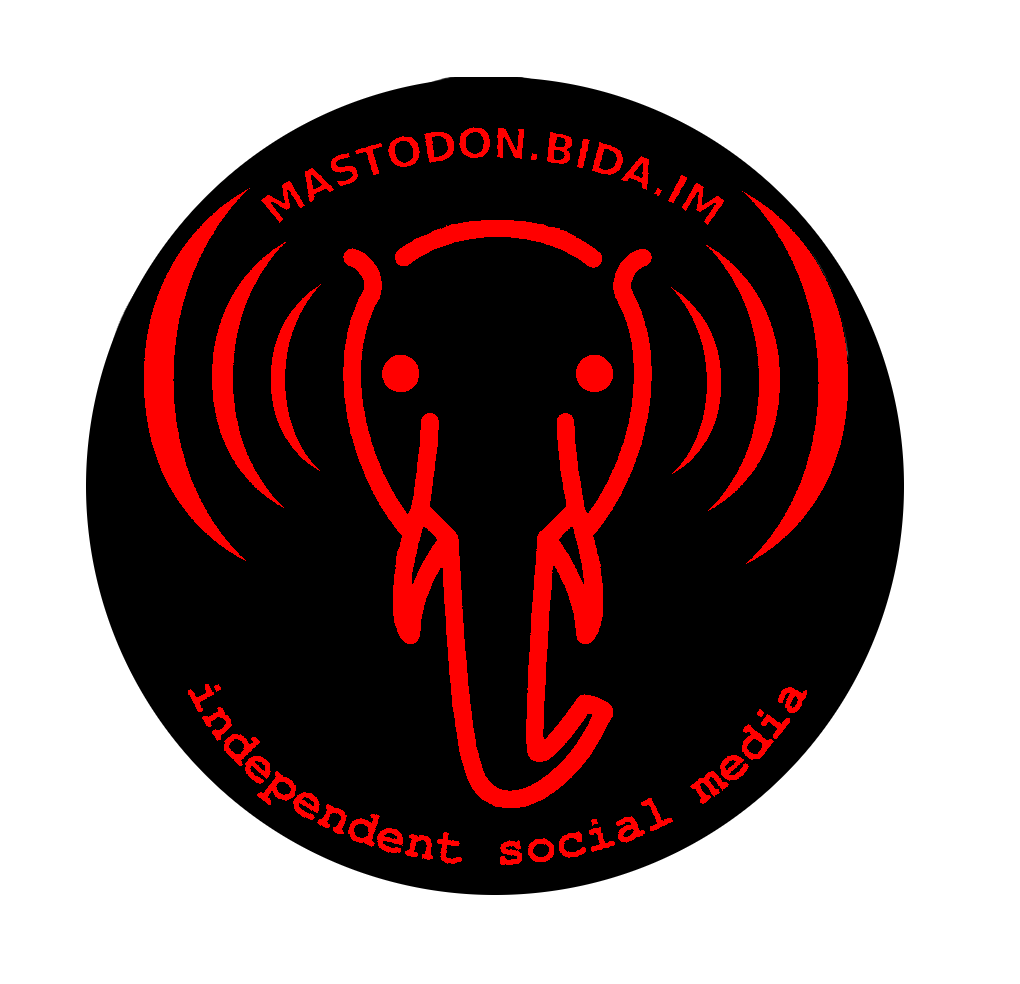Il seguente articolo, a firma mia e di J.R, è in uscita sul numero di questa settimana di Umanità Nova. Si inserisce nel complessivo lavoro di analisi sulla situazione statunitense che si sta portando avanti da anni e che si dovrebbe concretizzare a breve in una raccolta di materiale.
Prima di analizzare il risultato elettorale, la cui complessità non risiede solo nelle peculiarità del sistema di voto in sé ma nella struttura stessa dello Stato statunitense del quale è espressione, è opportuno analizzare brevemente la composizione dell’elettorato. Tralasciando per un attimo la middle class bianca, vorremmo focalizzare l’attenzione sull’elettorato afroamericano e latino. Una percentuale di circa il 90% di afroamericani aventi diritto al voto, elegge rappresentanti del Partito Democratico, è così da oltre cinque decadi ormai, dagli anni ‘60 sono divenuti una componente oramai stabile dell’elettorato democratico.[1] Ora il punto è che questa grossa fetta di popolazione statunitense vota democratico semplicemente perché non potrebbero mai votare per i Repubblicani, per motivi che sembra superfluo descrivere; non essendoci alternative elettorali al duopolio Repubblicani/Democratici si innescano questo tipo di automatismi.
L’automatismo porta il Partito Democratico a dare molte cose per scontate, fino a quando le proiezioni e i sondaggi non danno gli afroamericani su un trend astensionista, in tal caso arriva la cavalleria. Obama noto per le sue posizioni “energicamente centriste” è dovuto correre in aiuto del suo ex Vice Presidente per convincere un elettorato che teme di non essere sufficientemente rappresentato (cosa che sistematicamente si verificherà) a fare uno sforzo e votare compatti Biden, per mandare a casa Trump e un po’ per proseguire il percorso lì dove si era interrotto nel 2016.
Per quanto concerne la popolazione latinoamericana, la questione è un po’ diversa. Il radicamento e l’aumento di questa popolazione ha visto un’impennata negli ultimi cinquant’anni anni. Dal 1970 ad oggi la popolazione americana di origine ispanica è passata da 9,1 milioni di individui, fino a 57,4 milioni nel 2016, ossia il 17,8% della popolazione totale. Inoltre tra il 2016 e il 2017, più di metà dell’incremento demografico degli Stati Uniti è dovuto agli ispanici. In una serie di exit poll condotti dalla CNN e dal Pew Research Center nelle elezioni di midterm del 2018, si dimostra come il voto ispano-americano non sia polarizzato come quello degli afroamericani. [2] Si evince molto chiaramente una distribuzione affatto diversa da quella della middle class bianca (protestante o cattolica che sia) tra il partito democratico e quello repubblicano. Circa il 29% dei latino americani ha favorito i Repubblicani eleggendone un candidato. Questo la dice lunga tanto sugli scenari futuri quanto sulla sostanziale miopia della politica a stelle e strisce su quelle che ancora qualcuno continua a chiamare “minoranze”. Da un lato quindi il blocco afroamericano che oscilla tra astensionismo o voto per i Democratici, dall’altro gli ispanici che sostanzialmente aggiungono i loro voti alla fluttuante middle class bianca. La cosa più interessante è vedere come questa distribuzione demografica non rispecchia poi una proporzionale distribuzione di rappresentanti al congresso. Su 434 membri del 116° Congresso degli USA solo 54 gli afroamericani eletti alla Camera, mentre al Senato, solo tre. Per quanto riguarda gli ispanici ce ne sono 51 alla Camera e 5 al Senato. Considerando che afro e ispanici da soli costituiscono il 30,8% della popolazione le rappresentanze continuano a non rispecchiare il peso socio-economico dei due gruppi.
Quindi il corpo elettorale che ha votato in questi giorni non è assolutamente nulla di omogeneo o immediatamente interpretabile, e la crisi di rappresentanza da una parte e irrappresentabilità di molti dei candidati dall’altra tendono a rendere particolarmente arduo analizzare il voto dei cittadini dello Zio Sam. Quello che può però essere specificato è che le tensioni in atto nel Paese hanno comunque agito da sprone per una maggiore affluenza alle urne. Si è difatti passati dal 55,7% delle scorse presidenziali all’attuale 67%. Queste tensioni sono riconducibili all’incertezza che la pandemia sta generando verso l’immediato futuro ma non solo, il clima di odio raziale innescatosi durante l’amministrazione Trump ha inasprito condizioni già sostanzialmente instabili e latenti che si trascinavano da decenni e che avevano visto un effetto moltiplicatore nella cosiddetta big recession post crisi 2008. Queste linee critiche sono state vicendevolmente cavalcate tanto dai Democratici quanto dai Repubblicani, senza grosse o sostanziali modifiche alle cause strutturali di tali problematiche. Ovviamente le amministrazioni Obama e Trump, pur differenziandosi nel linguaggio e nel piglio istituzionale, sono due amministrazioni del centro nevralgico e propulsivo del pensiero Neo-liberista. Può al massimo stare più simpatico l’uno o l’altro, può essere l’uno più compito o l’altro più goliardico e istrionico, ma stiamo parlando della poltrona dello studio ovale, ossia un posto nel quale non entri se non sei comunque al servizio del mercato e del relativo ceto dominante.
Al di là della vittoria oramai incassata da Biden (stiamo scrivendo alle 20:38 del 7 novembre), rimane il problema di una vittoria per “mezza incollatura”, con il Senato sostanzialmente spaccato (attualmente 46 seggi a 48 per i Repubblicani) e una Camera con una presenza democratica di soli 214 seggi su 218 per assicurarsi la maggioranza. Dunque le problematiche di ingovernabilità appaiono molto concrete per la nascente amministrazione Biden. Quello che attende gli Stati Uniti è una serie di problematiche interne, dal contraccolpo economico del COVID-19 alle questioni razziali e che tendono a convergere nella questione del sistema sanitario e di previdenza sociale da un lato, ma anche di accesso al credito e all’abitare dall’altro. Sul versante estero ritroviamo intonsa la lotta economica con la Cina, la questione mediorientale, le rivolte in centro e sud America e ovviamente la questione NATO e la zona calda del mediterraneo. È oltremodo ovvio che di questi ambiti di conflitto politico ed economico all’elettore medio a stelle e strisce importa forse meno di nulla, ma questi agiscono spesso da calmiere in quella capacità tutta statunitense di sfruttare i grattacapi esteri come combustibile per incendiare l’orgoglio patriottico interno.
Trump non ha esitato a sfoderare tutto l’arsenale retorico sui “nostri ragazzi al fronte” (una volta tanto per richiamarli e non per mandarceli) o sul senso di responsabilità che la più grande potenza del mondo (ei fù) ha nei confronti di tutti e nel suo “dovere” di intervenire lì dove c’è disperato bisogno di democrazia (sic!).
Politica estera e futuri scenari
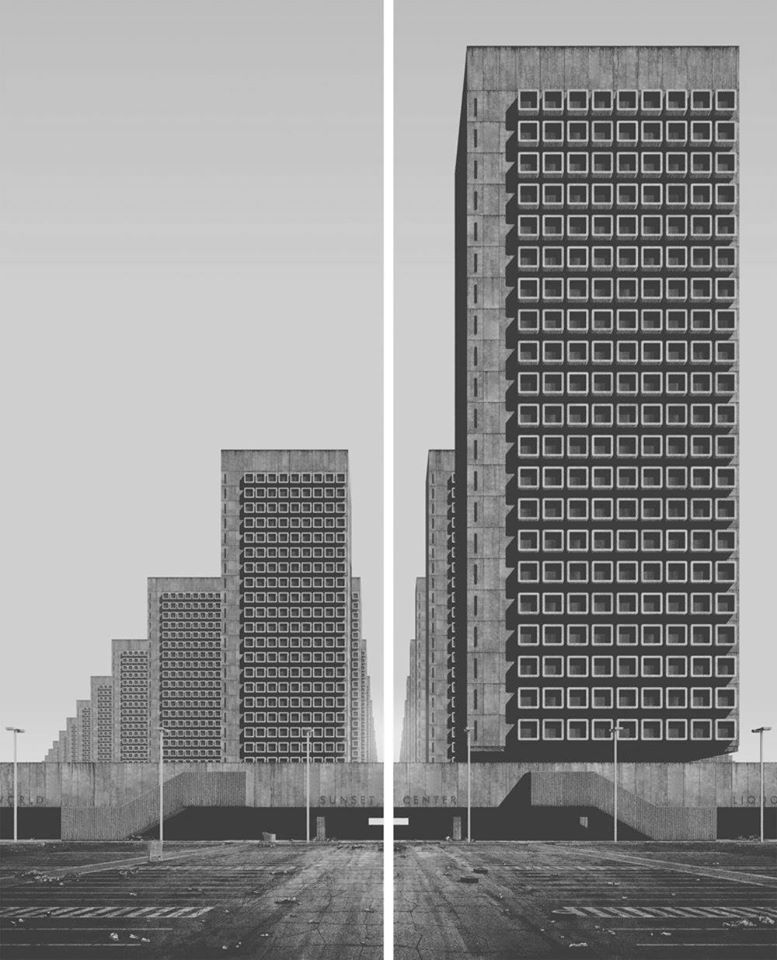 Biden dovrà ora raccogliere il lascito del suo improponibile predecessore, su una strada già segnata e assolutamente indipendente dalla volontà dell’inquilino della Casa Bianca. Una strada dettata dall’unica e sola esigenza che manda avanti il paese: garantire guadagni crescenti alle imprese private. Quindi ben venga il fatto di allentare la presa sul Medioriente lasciando sostanzialmente mano libera alla Russia, mantenendo comunque i due alfieri sul campo, Arabia Saudita e sodali da un lato e il fido alleato israeliano dall’altro. Due pezzi da novanta che hanno negli anni intessuto fitte reti di interessi da un capo all’altro del mega continente eurasiatico e che, al netto delle loro disastrose e criminali politiche interne, possono essere due poli contrapposti attorno a cui coagulare interessi di varia natura (magari anche contrastanti) ma con lo scopo di definire sempre dei punti critici rispetto ad una potenza regionale scomoda come l’Iran, o territori di conquista come la Siria o il Libano, segnati da conflitti o crisi profondissime e vicinissimi al tracollo.
Biden dovrà ora raccogliere il lascito del suo improponibile predecessore, su una strada già segnata e assolutamente indipendente dalla volontà dell’inquilino della Casa Bianca. Una strada dettata dall’unica e sola esigenza che manda avanti il paese: garantire guadagni crescenti alle imprese private. Quindi ben venga il fatto di allentare la presa sul Medioriente lasciando sostanzialmente mano libera alla Russia, mantenendo comunque i due alfieri sul campo, Arabia Saudita e sodali da un lato e il fido alleato israeliano dall’altro. Due pezzi da novanta che hanno negli anni intessuto fitte reti di interessi da un capo all’altro del mega continente eurasiatico e che, al netto delle loro disastrose e criminali politiche interne, possono essere due poli contrapposti attorno a cui coagulare interessi di varia natura (magari anche contrastanti) ma con lo scopo di definire sempre dei punti critici rispetto ad una potenza regionale scomoda come l’Iran, o territori di conquista come la Siria o il Libano, segnati da conflitti o crisi profondissime e vicinissimi al tracollo.
A fungere da sostituto per le politiche imperialiste in Medioriente è molto probabile che ci sia l’America centro-meridionale, è credibile che tutto il ciclo di recrudescenze destrorse e il restringimento dell’agibilità politica in molti Stati sia la diretta conseguenza del cambiamento strategico attuto dagli Stati Uniti, che hanno probabilmente optato per uno scenario di potenziamento dei mercati di prossimità per riequilibrare l’economia interna. Creare nuove aree di influenza, o rafforzare quelle esistenti, sostenendo governi ben disposti a mettere sul mercato tutto quello che di pubblico c’è (o è rimasto) è una strategia che dagli anni ’70 sembra essere l’unico attrattore che muove la politica estera di Washington. Soprattutto se i successi all’estero portano vantaggi per la ristrutturazione della domanda interna e nuove risorse con le quali stimolare (o sostenere) iniziative imprenditoriali derivanti da flussi di investimenti federali, che poi sono praticamente quelli che impediscono che il paese si arresti di colpo. Anche questa è una strategia rodata nei decenni, più fatturano le imprese più contribuiscono con le tasse e più investimenti il Governo farà sui programmi per gli alloggi, la sanità ai bisognosi ecc. basta non mettere lingua su come vengono fatti i soldi e non stare a sottilizzare se quei denari puzzano troppo: alla fin fine pacunia non olet.
Interni e scenari presenti: il dopo Trump
Se in politica estera le amministrazioni hanno assai meno problemi per giocare sporco, in politica interna hanno a che fare con la suscettibilità dell’americano medio: bianco, afro o ispanico che sia su certe questioni esiste una sconvolgente convergenza di pensiero, ossia chi paga le tasse, poche o tante che siano, vuol vedere i suoi diritti rispettati. È un mantra che ovviamente attecchisce in maniera differente in funzione dello status sociale. Ed è proprio questa una delle gatte da pelare che Biden si ritroverà tra le mani. Una popolazione impoverita rispetto al 2016, che chiede risposte, e che ha preso anche parecchie batoste, tanto dal COVID-19, quanto dai vari riots che si sono succeduti di recente. I disordini hanno sempre un certo effetto in una popolazione avvezza ad informarsi ancora da radio, TV e giornali, assai più che sul web o riviste di approfondimento. Quindi la psicosi da virus si è sommata a quella da riot e ha scatenato il solito teatrino tragico a stelle e strisce, compresi gruppi di preghiera per l’apocalisse eccetera. Ma al di là del folklore tipico di quelle latitudini rimane pur sempre un grosso problema di reddito medio in discesa.
Biden è praticamente un politico di professione, non avendo fatto altro dall’età di 29 anni, ma ha ricoperto ruoli via via più importanti nell’amministrazione governativa, come Presidente della Commissione Esteri del Senato, Presidente del Comitato di controllo sul narcotraffico internazionale del Congresso e Presidente della Commissione sulla giurisdizione del Senato. Tutte cariche conservate per alcuni anni, cariche tutt’altro che onorifiche ma piene di significato politico nel senso che la parola ha all’interno del Congresso americano. Ossia un ruolo di mediatore fra opposte fazioni che spesso ha alle spalle la mano tutt’altro che invisibile del mercato che richiede questa o quella decisione per tornare a trottare.
Come abbiamo più volte sottolineato sulle pagine di questo giornale [3] la questione della gerarchia razziale non è figlia di un “difetto morale”, come vorrebbe la vulgata liberale fatta propria anche dall’antiamericanismo di sinistra in europa, ma è una componente strutturale degli Stati Uniti fin dalla loro origine. Le rivolte degli ultimi mesi hanno visto centinaia di migliaia di sfruttati, abitanti dei quartieri popolari ma anche figli del ceto medio proletarizzato, scendere compattamente per strada saldando la questione di classe alla questione razziale. Se l’amministrazione Trump ha sicuramente contribuito a polarizzare le posizioni politiche, con la sua esplicita adesione al suprematismo bianco più retrivo, che non è solo quello delle zone rurali ma è un fenomeno proprio anche degli aggregati urbani, e Trump è espressione della classe dominate newyorkese e non della Bible Belt, le tensioni che abbiamo visto emergere in questi mesi sono energie carsiche pluridecennali. Il movimento Black Live Matters è nato in piena era Obama, con la rivolta di Ferguson, contemporaneamente ai movimenti indigeni che si sono mossi sulla questione del land grabbing attuato dall’industria petrolifera.
L’amministrazione Biden non vorrà e non potrà attuare quelle misure atte a garantire il reddito delle fasce di popolazione maggiormente colpite dalla crisi economica di questi ultimi mesi. E l’aumento della sperequazione nel priodo di ripresa seguente alla crisi del 2008 è figlio della politica economica obamiana.
Se la disoccupazione è diminuita, sia durante l’ultimo mandata di Obama sia durante durante il mandato di Trump, almeno fino all’ondata di COVID-19 – e sulla malagestione della pandemia Trump si è probabilmente giocato il posto – va tenuto conto che il livello di reddito non è aumentato come molti si aspettavano.
Insomma l’amministrazione Biden non sarà in grado di “sanare le ferite dell’America” come si augurano gli intelettuali progressisti. Nessuno è in grado di farlo.
La vittoria di Biden è una vittoria di misura. I sondaggi che gli davano venti punti percentuali di vantaggio si sono rivelati delle clamorose bufale. Fino all’ultimo Trump avrebbe potuto vincere, anche lui per un pugno di voti. E Biden non ha vinto grazie a un progetto politico capace di portare dalla sua parte milioni di persone: ha vinto perché milioni di persone hanno votato contro Trump. E non è detto che molti di questi domani non saranno pronti a scendere in piazza contro l’amminstrazione Biden.
È vero, comunque, che si scontrano due diverse visioni degli Stati Uniti. Da un lato intorno alla presidenza Trump si è coagulata la borghesia delle zone rurali, i centri dell’industria estrattiva in affanno e parte consistente della middle-upper class dei suburbi delle grandi concentrazioni urbane, tutti gruppi in affanno e che temono una perdita di potere a favore del “nuovo” capitalismo delle piattaforme che si dimostra più dinamico e aperto al cambiamento.
Dall’altro lato abbiamo le elitè culturali ed economiche delle grandi metropoli e dello stesso capitalismo delle piattaforme che si sono coagulati intorno al Partito Democratico, visto come erede di quel progetto di New American Century che il Partito Repubblicano, mettendo da parte la linea politica NeoCon – momentaneamente o per sempre non è dato a sapersi – e aprendosi alle istanze di quei settori di classe dominante e di middle-upper class in crisi aveva abbandonato.
Il progetto politico Democratico afferma che una gestione tecnocratica può essere più efficiente del vecchio sistema. Afferma di essere maggiormente in grado di gestire lo scontro, oramai conclamato, con la Cina, di saper raccogliere intorno agli Stati Uniti i tradizionali alleati atlantici.
In questo risiede la differenza tra i due gruppi che si contendono il controllo dell’amministrazione federale. Ma non dimentichiamoci che gli Stati Uniti, nonostante l’aumentato potere del governo centrale, non sono uno stato centralista.
Se il comitato d’affari che risiede a Washington ha sicuramente ampia voce in capitolo per quanto riguarda la politica estera e per quanto concerne la politica economica, tramite la Federal Reserve, tutti gli altri aspetti sono demandati a livello locale. E non parliamo di questioni di poco conto: i bilanci di alcuni stati dell’Unione sono imponenti e la scelta di indirizzare la spesa pubblica verso questo o quel settore ha impatto importante sulla vita di chi abita in quei luoghi. Ai singoli stati è demandata buona parte della legislazione sul lavoro, l’amministrazione giudiziaria, le politiche urbane, la gestione delle infrastrutture. E il mantra neoliberista accomuna Democratici e Repubblicani.
Ovviamente questo significa anche che movimenti sociali che da qua appaiono come locali sono in grado, invece, di ottenere importanti vittorie, sia sul piano economico, pensiamo alla mobilitazione degli insegnanti in West Virginia [4] o delle lotte per il salario minimo a 15 dollari/ora, in diversi casi vittoriose, o, ancora, all’impatto di interi distretti di aree metropolitane che si riversavano compatti in strada a chiedere il definanziamento delle forze di polizia (e in certi casi l’abolizione delle stesse) a favore di investimenti in welfare state.
Certamente noi rimaniamo critici verso le rivendicazioni welfaristiche [5] ma intanto vediamo abbozzi di autorganizzazione crearsi nelle contraddizioni che questi movimenti disvelano.
Una certa narrazione pretende che nei paesi del centro del sistema-mondo non possa succedere nulla di interessante in termini di movimenti sociali. Gli ultimi dieci anni di storia negli Stati Uniti ci dimostra proprio il contrario.
Note
-
Olivier Richomme, “The post-racial illusion: racial politics and inequality in the age of Obama”, consultabile su:https://journals.openedition.org/rrca/464
-
“Historic highs in 2018 voter turnout extended across racial and ethnic groups”, by Jens Manuel Krogstad, Luis Noe-Bustamante and Antonio Flores, consultabile su:https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/historic-highs-in-2018-voter-turnout-extended-across-racial-and-ethnic-groups/
[3] Tradire la “razza” bianca significa essere fedeli verso l’umanità: https://umanitanova.org/?p=12322
[4]La lotta degli insegnanti del West Virginia – https://umanitanova.org/?p=7805
[5]Note e riflessioni sui percorsi di incompatibilità: https://photostream.noblogs.org/2019/06/note-e-riflessioni-su-percorsi-di-incompatibilita/
Ps fuori articolo: in un precedente articolo, The Age of Quarrel, avevo previsto Trump vincitore con strettissima misura. Invece ha vinto Biden, di strettissima misura. Insomma: avevo previsto come si sarebbe vinto ma non chi. Direi che la mia idea di dedicarme alle scommesse delle corse sfuma.