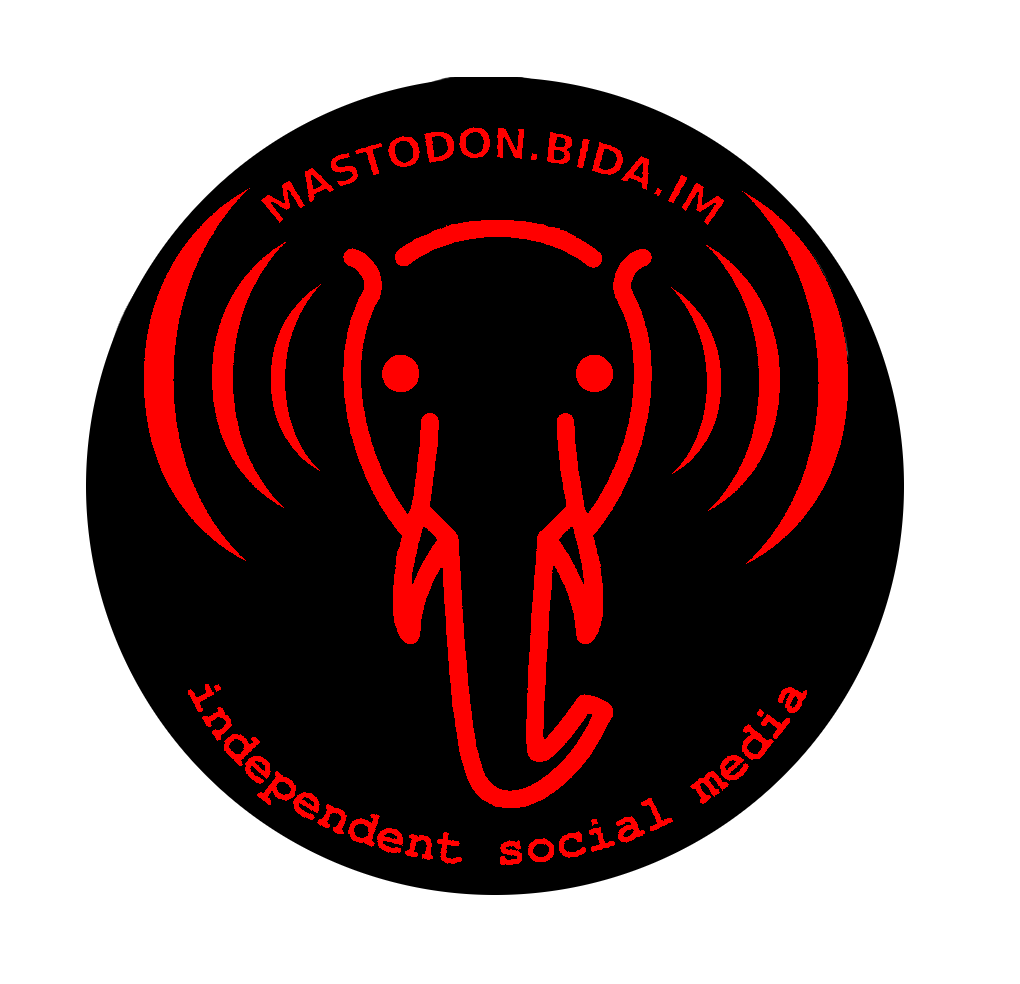Di seguito un documento presentato al dibattito del XXX Congresso della Federazione Anarchica Italiana, tenutosi a Massenzatico nell’Aprile del 2019, e successivamente pubblicato su Umanità Nova.
NOTE E RIFLESSIONI SU PERCORSI DI INCOMPATIBILITÀ
Indice generale
NOTE E RIFLESSIONI SU PERCORSI DI INCOMPATIBILITÀ 1
1.1 La narrazione nella post modernità 1
1.2 Cosa c’è da perdere che non abbiamo già perso 3
1.3 Le sperimentazioni orfane 4
2.0 Del reddito o dell’incompatibilità di sistema 6
2.1 Reddito, lavoro e la società del consumo 6
2.2 Il reddito tra mutualismo e conflitto 9
1.0 La fase
 L’analisi negli ultimi anni, a partire, almeno, dall’inizio del ciclo di crisi nel 2008, si è concentrata molto sulle contingenze e le congiunture, sul qui e ora, più che sulle dinamiche strutturali che hanno determinato l’attuale assetto storico. Uno sguardo ampio sui meccanismi profondi che regolano la società e il peso che la politica rappresentativa e l’economia esercitano su concetti come reddito, lavoro e coesione, tarda a farsi strada.
L’analisi negli ultimi anni, a partire, almeno, dall’inizio del ciclo di crisi nel 2008, si è concentrata molto sulle contingenze e le congiunture, sul qui e ora, più che sulle dinamiche strutturali che hanno determinato l’attuale assetto storico. Uno sguardo ampio sui meccanismi profondi che regolano la società e il peso che la politica rappresentativa e l’economia esercitano su concetti come reddito, lavoro e coesione, tarda a farsi strada.
Per correttezza e coerenza va fatto presente che in molti casi si sono tentati dei timidi passi a lato, in modo da poter sfruttare la prospettiva per una foto a grande angolo della realtà, ma insufficiente è stata la distanza presa per apprezzare l’interezza delle problematiche in atto.
Procederemo quindi tentando di analizzare la fase con un minimo di ordine, partendo da cosa non è stato fatto e di cosa non si è tenuto conto, dei passaggi non fatti e delle sintesi mai abbozzate (seppur a portata di mano).
1.1 La narrazione nella post modernità
A livello storico e sociale dal 78’ all’89’ è avvenuto un collasso delle istanze movimentiste, protrattosi poi per tutti gli anni 90’ per una serie di relazioni complesse innescatesi nella società europea in generale e italiana in particolare, il benessere ha senza dubbio contribuito a far abbassare la guardia, le conquiste dei lavoratori hanno fatto ben sperare di aver superato un punto di non ritorno, ritenendo indiscutibili queste ultime, e proiettando l’immaginario in un futuro che poteva solo evolvere in meglio.
Sul piano socio-politico si chiudevano le esperienze della lotta armata e delle organizzazioni extraparlamentari, si compiva uno strappo sociale, tutt’ora non sanato, nelle rappresentanze parlamentari, cominciava a farsi strada il concetto di irrappresentabilità, non a livello categoriale, ma a livello di tessuto sociale, si andava quindi aprendo un baratro fra le istanze dei rappresentanti e le esigenze dei rappresentati. Il meccanismo della delega in bianco ha sbilanciato un sistema che, tra mille contraddizioni, aveva retto per le prime quattro decadi della Repubblica. Con scarsi risultati si è cercato di incardinare le istanze di rappresentatività con una lettura di classe, lettura che appariva, e che purtroppo tutt’ora appare, orfana del significato stesso di classe. Gli anni 80’ hanno spazzato via il senso stesso dell’essere classe, il benessere e il nascente mercato completamente globalizzato hanno drogato le analisi sociali e politiche fino a far coincidere le istanze borghesi con quelle dell’autentico progresso, facendo dimenticare a molti che chi vive del proprio lavoro è e rimane nell’ambito del proletariato pur se libero e, talvolta, affermato professionista.
Mancando un ragionamento organico i tentativi sono spesso stati parziali, vuoi per la sfiducia che certi concetti avevano oramai causato vuoi per il fatto che lo scenario non appariva più drammatico, con la disoccupazione in calo, il PIL in crescita e la stagione delle bombe sui treni e nelle piazze oramai alle spalle. Un senso di speranza ha inebetito la società in maniera direttamente proporzionale all’aumento del salario. Un altro aspetto, spesso non considerato nella giusta prospettiva, è stata la progressiva sparizione di partiti cosiddetti di sinistra, che rappresentando un contro altare, creavano quel distinguo negativo nel quale il movimento, pur nella sua variopinta e caleidoscopica natura, ha perpetuato spesso la sua ragion d’essere. Sparendo il PCI è mancato l’antagonista istituzionale per eccellenza, quindi le costruzioni teoriche che agivano in funzione dell’essere in un rapporto dialetticamente conflittuale con “il Partito”, hanno mostrato il loro limite, e sono sparite quasi contemporaneamente al partito stesso. Si è passati dalla militanza alla spontanea aggregazione di individui fino alla creazione delle “zone franche” dei centri sociali, che con alterne fortune, hanno comunque costituito un passaggio storico di arretramento e chiusura a riccio, nella strenua resistenza contro un nemico che si faceva di giorno in giorno sempre più difficilmente riconoscibile. il fatto può spiegarsi sia nelle mutate condizioni sociali, sia nella profonda crisi di alcune teorie politiche, che negli anni 90’ sono state ridimensionate, demolite, ricusate e infine quasi abbandonate.
Se da un lato si proponeva il superamento delle utopie con una profonda critica ai grandi pensieri (e pensatori) dell’800’, talmente profonda da rasentare il revisionismo in taluni casi, dall’altro il mantra Thatcheriano, dell’inconsistenza del concetto di società, sostituito dai singoli individui e dalle famiglia, come unità base di riferimento per i consumi, cominciava a demolire alla radice l’essenza stessa della coesione sociale. Altro tassello non meno importante è stato il cambiamento del valore sociale della figura dell’operaio, visto fino a quel momento come unità di misura: sul salario dell’operaio si misurava il livello di benessere di una intera nazione, in quanto rappresentava il primo livello di reddito, l’unità base, il livello minimo.
La stagione delle lotte aveva quantomeno creato dei livelli di riferimento chiari e comprensibili, di ascesa e discesa sociale. Tutto ciò è cominciato a deteriorarsi, in quanto la tenuta dell’unità di misura è legata al non solo al fatto che la parte di società di cui questa è espressione continui a rivendicarla come propria, ma è conditio sine qua non che si continui a costruirci sopra delle aspettative. La risposta è stata un gioco al recupero della capacità di spesa e non dei principi che sottendevano le conquiste storiche. Questo va tenuto a mente per capire l’attuale confusione delle rivendicazioni.
Se da un lato c’è stato un arretramento analitico, una progressiva incapacità di mettere in luce le contraddizioni, per concentrarsi sul mero piano delle rivendicazioni, dall’altro si è via via spostata l’attenzione da un piano utopico ad un piano di successive visioni miglioristiche dello status quo, un progressivo “disincanto” e una ricerca pragmatica di rintracciare all’interno dello stesso sistema, le vie d’uscita dalle problematiche che venivano create dai processi di riproduzione del capitale. Al mantra della fine delle ideologie ha quindi fatto eco l’abbandono di “prassi analitiche” e la dialettizzazione dei problemi è stata sostituita dalla problematizzazione della dialettica spalancando le porte al pensiero postmoderno che ha inoculato il virus della visione a senso unico per eccellenza; il neoliberismo.
Uno sconvolgimento radicale e profondo ha rovesciato i paradigmi storici di declinazione della realtà come narrazione del conflitto tra capitale e lavoro, sostituendovi la narrazione dell’indefinita possibilità tecnologica, delle successive approssimazioni e dell’inutilità di narrazioni totalizzanti. L’esito è che stiamo dentro ad una narrazione che ha già totalizzato il reale autodefinendosi come unico orizzonte possibile, eliminando il concetto stesso di altro da sé, anche le esperienze e le sperimentazioni che pretendono di porsi fuori da questa, non fanno altro che assumere gradi di compatibilità differenti dalla norma, ma senza mai uscirne o porsi in una reale controfase, o genuina e originale incompatibilità.
1.2 Cosa c’è da perdere che non abbiamo già perso
I tentativi che si sono succeduti, simili nelle prassi e diversi solo nelle parole d’ordine, sempre orientati alla creazione di un consenso o all’addomesticazione di un’opinione, da opporre alla narrazione totalizzante neoliberista, si sono dimostrati fallimentari, in quanto partivano sempre dalla volontà di decostruire le sovrastrutture, lasciando intonsa la struttura profonda del problema. Le stesse lotte studentesche dalla Pantera all’Onda, pur con analisi differenti, hanno fatto emergere la contraddizione senza scalfirla, anzi costruendo su di essa un immaginario di possibilità, assolutamente compatibili con il sistema.
Il punto di rottura non si è mai raggiunto, ossia non si è mai sperimentato un reale processo di successivi livelli di incompatibilità ed emancipazione con la narrazione neoliberista. La stessa ricerca di creare network di controinformazione ha fallito in quanto agente e operante nell’assurda convinzione che l’accesso alla rete equivaleva ad avere accesso allo strumento informativo per eccellenza, da qui il tentativo di rivaleggiare, con il main stream, senza averne la stessa capacità organizzativa, su base spontanea e colloquiale, senza una strategia chiara.
L’esito è stato l’allontanamento dalle istanze di movimento di soggetti molto capaci che hanno ripiegato sulla creazione di blog personali rinchiudendosi dentro analisi specifiche di singole tematiche, contribuendo ad aumentare l’entropia informativa, fino all’attuale rumore. I tentativi, per giunta sempre più inefficaci, di aggregare in nome di una non meglio definita moltitudine che dovrebbe spontaneamente creare una massa critica d’impatto, stanno mostrano la loro inconsistenza di fondo, riducendosi ad eventi stagionali, assembramenti che assumono sempre più la connotazione di fine ultimo, o di misura del livello di egemonia di un’area sulla capacità di mobilitazione del movimento.
L’esito è che di anno in anno, di stagione in stagione, si devono mostrare i muscoli per dimostrare a sé stessi di esistere, e si investono energie sempre più scarse in manifestazioni nazionali sempre meno convinte, con piattaforme sempre più dilatate per tenere dentro tutto e il contrario di tutto, per fare numero, addizione di realtà e singoli individui, che il più delle volte non reggono oltre l’evento.
Una deflagrante spontaneità e una ricerca di informalità dettate dal rifiuto di qualsivoglia istanza organizzativa, ha contribuito a erodere ulteriormente le già fragili basi politiche su cui poggiava lo zoccolo duro del movimento. La spasmodica ricerca dell’agire pur di non rimanere fermi o di perdere il passo con altre parti del movimento ha innescato processi nei quali le analisi dei perché lasciavano spesso spazio alla tattica del come fare.
Istanze aggregative, oramai orfane di un ragionamento atto a delineare il perché dell’aggregare, giocano al rilancio senza preoccuparsi troppo di chi si aggrega e dietro quali motivazioni, si cercano parole d’ordine che catturino per un istante l’immaginario, sperando nella creazione di punti di accumulazione e che di stagione in stagione cambiano. Il processo di preparazione stagionale si riduce spesso all’elaborazione di nuove proposte e nuove parole, analisi usa e getta e pratiche riciclate da successi oltre mare o oltreoceano.
La duplicazione delle ricette movimentiste o rivoluzionarie, l’esser stato protagonista, l’ospite d’eccezione da sbattere su un manifesto o da contendere per le varie iniziative, il tutto sempre più velocemente, senza tempo per riflettere e capire il contesto in cui siamo inciampati. Una becera mimesi della velocità di consunzione del capitale, veloci sempre più veloci ad inseguire date e scadenze regionali, nazionali e internazionali.
Quel che esce fuori dai ranghi del movimento, non si annichilisce, non diventa silente, ma cerca altre strade o si istituzionalizza, una responsabilità storica e politica va riconosciuta e assunta, al di là di liberatori “mea culpa”. Il sopravanzare delle nuove destre è si acuito dalla crisi, dalla straordinaria stagione migratoria e dall’esodo di profughi da svariate parti di Asia e Africa, ma lo spazio di manovra lo hanno rosicchiato da quello lasciato dall’assenza di progettualità territorializzata.
I cinque stelle hanno raschiato, rastrellato e raggranellato tutto quel che restava fuori dai processi ciclici di flusso e riflusso del movimento, pescando qui e lì anche tra i fuoriusciti di partiti, piccoli e grandi, in cerca di un’ora di gloria in un organismo nascente. Quel che si perde non è mai perduto, rifluisce sempre altrove, ma quasi mai torna indietro. Dopo aver perso identità di classe e capacità di analisi, dopo aver perso credibilità in nome di un non meglio identificato bisogno di unire gli opposti, dopo aver perso progressivamente contatto con il territorio e forse anche il contatto con la realtà cos’altro resta da perdere?
1.3 Le sperimentazioni orfane
Negli anni recenti si è spesso dibattuto su varie tematiche legate ai diritti e alle relative riappropriazioni. Dal diritto alla casa, all’insegnamento, alla sanità finendo, con un processo quasi filologico, all’enucleazione del diritto al reddito, il che ha potenziato i ranghi di coloro i quali valutavano positivamente il reddito di cittadinanza o reddito universale o reddito sociale. Al di là del reale significato e delle confusioni con altri strumenti economici o di welfare (vedi il basic income) quel che è interessante notare è come si sia progressivamente prodotta una mutazione nelle rivendicazioni sociali.
Il rivendicare una redditualità diretta (monetaria) ha aperto nuove visioni nell’immaginario collettivo, rendendo compatibili, con l’esistenza nell’era dei consumi, meccanismi quali il precariato, se si immagina di poter rimpinguare il gap salariale con un minimo garantito, allora si è ben disposti a percepire paghe ridotte o a pagare un canone locativo lievemente più alto o subire in maniera passiva la privatizzazione e l’aziendalizzazione dei pubblici servizi. Si rende socialmente accettabile un passaggio epocale, ossia il sostegno indiretto alla produzione dei servizi, con un trasferimento di risorse dalle casse statali alle casse delle aziende passando dalle tasche del cittadino medio.
Ma questa non è che la parte emersa del problema, il cambio di prospettiva del reddito diretto come diritto ha di fatto distorto le prospettive di un immaginario collettivo, che ora rivendica denaro e non si muove, invece, nell’ottica dell’autonoma conquista di un miglioramento delle condizioni di vita; o peggio, rivendica il denaro come strumento di acquisizione di diritti. Il reddito è oggetto di dibattiti complessi, ma la sua centralità è sempre stata vista come positiva, mai come problematica da decostruire.
L’esigenza del reddito è centrale, ma come molte esperienze e discussioni non hanno mai creato le doverose istanze di incompatibilità con il sistema (in questo caso la declinazione utile è quella del sistema mercato) ci si ritrova a dibattere su come riappropriarsi di reddito, o di liberare spazi per un libero ottenimento dello stesso, svincolato da leggi e regole, nella speranza che questo basti ad avviare un processo di reale emancipazione dai dettami del sistema mercatale di riproduzione del reddito.
In realtà si liberano risorse e si creano dei micro ammortizzatori sociali attraverso l’economia informale, che nel complesso sgrava lo Stato e il sistema in generale, da alcuni obblighi e oneri. In questo complesso flusso di dibattiti e analisi è spesso sfuggito il concetto stesso di reddito e cosa invece potrebbe configurarsi come suo sostituto, nell’ottica di ricostruire una ricomposizione sociale, ossia il riappropriarsi dei mezzi per la produzione di reddito indiretto, cioè beni e servizi non mediati dalla quantità di moneta, in breve recuperare il valore d’uso nell’ottica di dissacrare il valore di scambio.
Quello che colpisce è che nella rincorsa del reddito, spesso si sottovaluta la direzione verso la quale si avvia la rivendicazione, si perde di vista il fatto che ciò che si chiede è la crescita economica nella sua più genuina formula economica Neo-classica, ossia la generalizzata crescita del reddito pro capite. Che a chiedere ciò sia la classe media, in un tentativo di recupero del suo potere di spesa, quindi dei suoi storici privilegi, non sorprende; il problema e la contraddizione esplodono, quando queste istanze divengono le parole d’ordine di un intero movimento e di una intera generazione che chiede semplicemente accesso al reddito, cioè potere d’acquisto.
Quindi si ammantano di connotati rivoluzionari alcune pratiche tendenti a scavare nicchie nel mercato globale, che non emancipano dalla necessità del reddito diretto, ma anzi ne fanno il fine ultimo, costruendovi attorno una serie di rapporti, che su scala ridotta mima la complessità della produzione di massa. Orfane di un preciso percorso politico di reale incompatibilità, molte sperimentazioni concedono molto di più di quel che ottengono e lo sforzo di realizzare un profitto, depotenzia e dirotta le energie dal movimento alla produzione. Va anche ricordato che tale produzione trova una domanda in quegli strati sociali che hanno una discreta capacità di spesa, in un paradosso tipico del nostro tempo: si tenta di combattere il soggetto sociale che sostiene lo sforzo, ci si trova quindi ad essere mantenuti esattamente da quel soggetto contro il quale si è convinti di lottare.
2.0 Del reddito o dell’incompatibilità di sistema
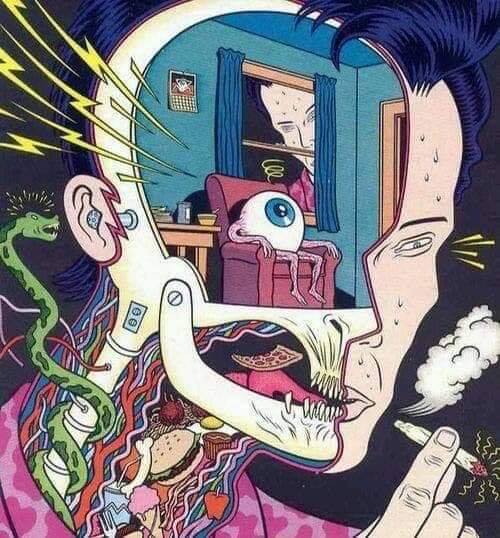 Il discorso è incentrato sull’analisi di alcuni aspetti contraddittori legati alla ricerca di percorsi emancipativi, che il “movimento” sta tentando di mettere in pratica negli ultimi due lustri. L’analisi viene portata avanti partendo da alcuni concetti base, quali la redditualità diretta, la redditualità indiretta e il mutualismo, associati a questi si pone l’obbligo di ridefinire talune strategie e recuperare alcuni particolari significati.
Il discorso è incentrato sull’analisi di alcuni aspetti contraddittori legati alla ricerca di percorsi emancipativi, che il “movimento” sta tentando di mettere in pratica negli ultimi due lustri. L’analisi viene portata avanti partendo da alcuni concetti base, quali la redditualità diretta, la redditualità indiretta e il mutualismo, associati a questi si pone l’obbligo di ridefinire talune strategie e recuperare alcuni particolari significati.
Nello specifico, prima di affrontare i concetti base, è utile un ragionamento per inquadrare il problema dal punto di vista storico e sociale, si farà quindi riferimento ad un processo necessario, che qui viene definito di “identificazione”, ossia il processo di percezione del proprio ruolo all’interno di un contesto storico, economico, sociale e politico. Processo a priori, rispetto alla ricostruzione del concetto, oramai svuotato di senso, di identità di classe.
Il secondo significato, oggetto dell’analisi, è quello dell’incompatibilità col sistema, la quale si esplica come elemento essenziale per innescare una rottura sostanziale – quindi strutturale – con il sistema. L’incompatibilità è la prima importante fase da concepire, senza la quale si intraprendono percorsi che si ammantano di velleità antagoniste o di conflittualità col sistema ma che, nella sostanza, cercano di scavare nicchie comode all’interno dello stesso: nella fattispecie nicchie di mercato.
E’ chiaro che ci si muove nell’ambito di una critica radicale condotta con gli strumenti della decostruzione delle narrazioni ufficiali – la mercificazione totale e il mercato come unico orizzonte di senso possibile – e delle contro narrazioni “antagoniste”, ossia la ricerca di forme alternative per l’ottenimento di reddito apparentemente fuori dalla logica mercatale.
2.1 Reddito, lavoro e la società del consumo
Il lavoro, nella sua essenza di processo trasformativo, non è una prerogativa dell’essere umano; macchine e animali possono svolgere molte mansioni, ma soprattutto le macchine le quali, in ragione dell’avanzamento tecnologico, tendono a sostituire il lavoro umano. Quindi il lavoro in sé, come fonte di profitto per chi lo utilizza, organizzandolo in un processo razionale, potrebbe fare a meno dell’essere umano se si potesse affidare ogni mansione ad un sistema meccanizzato o elettronico. Per quanto fantascientifico possa apparire, è quello che si sta realizzando, ma questo non è un problema nuovo che attanaglia la contemporaneità, esso fu ipotizzato già nel momento stesso in cui si ravvisavano le prime innovazioni tecnologiche nel campo industriale.
Si può immaginare sul lungo periodo che si raggiunga un equilibrio nello sviluppo globale del pianeta, ma non si può chiedere a chi versa in angosce quali la segregazione sociale e la povertà di sperare in un ipotetico futuro migliore, ammesso e non concesso che gli sconvolgimenti climatici non ci spazzino via anzitempo. Forse spostando l’attenzione dal problema del lavoro in termini quantitativi, al problema del lavoro in quanto fattore di riproduzione che può essere surrogabile con altro, ci indurrebbe a rivedere alcune scelte del passato e rimodulare le azioni del presente.
Discutere sul significato del lavoro non equivale quindi a definirne il senso, il fatto che la domanda più pertinente della nostra contemporaneità ruoti attorno al senso del lavoro, dovrebbe far risuonare qualcosa nelle menti di coloro i quali negli anni si sono sempre dimostrati attenti ai cambiamenti.
Molte cose sono cambiate definitivamente nell’ultimo quarto di secolo, alcune stanno cambiando molto rapidamente, per altre il cambiamento è sempre stato implicito nella loro natura; purtroppo ci si è spesso attardati nell’affrontare i sintomi dei mutamenti senza scendere alle radici stesse del problema.
Declinare il senso del lavoro nel momento in cui esso sta profondamente mutando la sua essenza in quanto fattore di riproduzione sociale, mette in luce il ritardo analitico nel quale stiamo annaspando. Ritardo spesso assecondato da richieste di ripristinare lo status quo invece di tentare di mettere in discussione tutto il sistema. Negli anni passati si inneggiavano slogan contro la globalizzazione spesso non avendo idea di cosa fosse fino in fondo, ora che stiamo guardando i suoi effetti, spesso non ci viene in mente nulla di meglio che esigere redditi più alti e lavori stabili, questo vuol dire continuare a sottovalutare la portata del fenomeno.
Non è quindi semplice decifrare il senso del lavoro nella nostra contemporaneità senza comprendere fino in fondo cos’è il processo di globalizzazione e quali sono gli scenari che ha contribuito a chiudere e quali quelli che sta aprendo. Il lavoro e la struttura economica sono molto più che fattori interdipendenti, sono elementi costitutivi dello stesso sistema, che pur essendo influenzati dai medesimi processi assumono ruoli diversi all’interno del meccanismo di riproduzione del capitale.
L’avanzamento tecnologico aumenta la velocità di trasferimento dei servizi, delle risorse e del capitale, fino al punto in cui i flussi di investimento e i trasferimenti di denaro sono praticamente istantanei e virtualmente senza confini, mentre la velocità di trasferimento della forza lavoro oltre ad essere dettata dai tempi di trasporto è limitata dai confini istituzionali.
Quindi da un lato i servizi e le merci non conoscono (o quasi) barriere, mentre il lavoro è bloccato e territorialmente circoscritto (Stiglitz 2015). L’innovazione tecnologica quindi crea le condizioni sulle quali si costruiscono nuovi scenari e sulle quali vengono ad essere impostate le istanze di cambiamento della struttura socio economica mondiale. L’implementazione del sistema dei trasporti e dell’informatizzazione della logistica, ha contribuito in maniera assai profonda alla ridefinizione di tempi e costi attraverso un processo di efficientamento a livello mondiale.
Ciò ha favorito la delocalizzazione della produzione in aree nelle quali il costo del lavoro è concorrenziale, addirittura con l’avanzamento tecnologico. Ma al di là di alcune eccezioni, il processo congiunto di delocalizzazione e robotizzazione sta rendendo problematica la gestione delle residualità di lavoratori attualmente impegnati in Europa e Stati Uniti. Per questi lavoratori l’economia neoliberista non è in grado di trovare una collocazione, se non chiedendo programmi statali di accompagnamento “dolce” alla disoccupazione, il workfare state inglese o il sistema Hartz IV tedesco, o disciplinando la forza lavoro in eccesso tramite lavori a bassa qualifica che sarebbero fin da ora in buona parte automatizzabili, come la logistica delle merci.
Quindi abbiamo da un lato lavori che tendono a sparire perché semplicemente sono rimpiazzati o da automi o da esseri umani che costano meno da qualche altra parte, mentre quel poco che resta è spinto dal principio di massimizzazione della produttività. Dal momento che un lavoratore in Europa “costa troppo”, allora devo farlo lavorare più intensamente nelle 8 ore, solo così posso parzialmente bilanciare lo svantaggio competitivo di lasciare la produzione in loco.
Quindi un paradosso potrebbe essere il seguente; si riduce il personale e quello che resta viene sottoposto a ritmi molto intensi e usuranti, chi perde il lavoro (soprannumerario o semplice contestatore del ritmo produttivo) lotta per essere riassunto in un posto di lavoro parimenti logorante o comunque destinato a sparire, per opera della delocalizzazione o per opera dell’automazione. Da qui nuovamente la domanda circa il senso del lavoro e il significato che assume il lavoro salariato nella nostra fase storica, seguendo il ragionamento fino alle sue conseguenze ultime, si approderebbe al nocciolo del problema e al fatto che il lavoro è l’unica attività che consenta la creazione di reddito monetario individuale, da qui la domanda basilare, sul significato autentico di reddito, il suo scopo nell’attuale struttura socio economica mondiale.
Quindi in occidente quale senso ha oggigiorno il lavoro salariato nel momento in cui si è deciso che non serve più? Quindi se non è più il lavoro umano salariato, la componente principale di riproduzione del capitale come si mantiene la società dei consumi? La risposta non è semplice, l’analisi delle attuali tendenze del mercato del lavoro, inducono ad immaginare lo sviluppo di una sorta di “operaio non manuale”. Figure professionali iper-specializzate in mansioni tecnico-pratiche o procedurali, sono questi i casi della catena della logistica nella quale il facchinaggio è una componente numericamente bassa di tutta la forza lavoro impiegata, costituita in maggioranza da magazzinieri, tecnici meccanici o informatici che assistono e controllano le macchine.
Ma in tutto ciò viene introdotto anche un altro grosso cambiamento sociale, fino agli anni 80’ il salario era la misura sociale della ricchezza, sotto quel livello si era considerati poveri, su quel livello si faceva una vita “normale”, superato il salario dell’operaio specializzato o con anzianità cominciava la borghesia: dalla piccola borghesia impiegatizia ai liberi professionisti in su. Oggi questo ordine non solo è mutato, ma non vi è più uno strato sociale di riferimento che faccia da spartiacque tra il ricco e il povero, tutto è divenuto piuttosto relativo se si considera il possesso di strumenti tecnologici o il possesso di una vettura.
Il senso del lavoro, come elemento di emancipazione sociale, ha finito per dimostrarsi la menzogna che è sempre stata. Il lavoro emancipa solo nella misura in cui si è liberi acquirenti ed “eleva” solo nella misura in cui l’individuo vorrebbe guadagnare di più per acquistare di più. In quest’ottica il fordismo è ancora presente come orizzonte di benessere economico cui tendere. Ma come fare ad uscire dal vicolo cieco in cui versa attualmente l’occidente è un’incognita alla quale si deve prestare attenzione, sono su queste elaborazioni e su queste proposte che si giocano i futuri equilibri sociali o le strategie per ammansire gli individui.
Qui entra in gioco l’asso nella manica, la teoria legata ai redditi di cittadinanza o in una visione ancora più “estrema” al basic income. Ossia redditi monetari elargiti dallo stato e prelevati attraverso dei meccanismi fiscali, atti a compensare il fatto che – almeno in occidente – il concetto di lavoro umano sta progressivamente abbandonando il campo. In molti ci vedono il compimento di una società libera e felice, altri il compimento della supremazia dello stato, altri una schiavitù senza catene ecc. ecc. A parte la differenziazione tra i redditi derivanti dal workfare e il basic income, aventi due significati assolutamente distinti, il concetto di base rimane grossomodo invariato, qualcuno deve darti quattrini perché il tuo lavoro non serve più.
Per quanto concerne invece in basic income, o reddito universale, se da un lato elimina la retorica del merito sulla quale si sostiene invece il workfare, in quanto sarebbe un fisso mensile per tutti, ricchi e poveri uomini e donne singoli e famiglia – quindi cumulabile – dall’altro apre l’interrogativo circa la provenienza di questo salario universale. Uno dei principali sostenitori del basic income è il professor van Parijs il quale quantifica il reddito universale come percentuale sul PIL nazionale (dal 15 al 25%) divisa per tutta la popolazione residente maggiore di 18 anni, l’esborso dovrebbe autofinanziarsi con l’eliminazione di tutti gli altri sussidi, comprese le pensioni.
Senza scendere nel dettaglio fine sulle reali fattibilità di questo strumento, le implicazioni sono assai semplici da essere dedotte, chi contesterà la crescita del PIL per ottenere la quale si è disposti ad esempio a svendere pezzi di territorio all’imprenditoria selvaggia o ad intraprendere campagne militari per mantenere alta la produttività e accaparrare risorse offshore? Ma tentiamo un’altra via per finanziare il reddito universale, immaginiamo una Tobin Tax, quindi un prelievo di qualche centesimo percentuale sulle transazioni del mercato azionario che sostenga l’esborso statale.
Ebbene in questo caso sarà difficile poi convincere le persone che la speculazione finanziaria genera crisi sempre più ampie dal momento che più si specula più danari entrano nelle tasche di tutti. La crescita lineare indefinita non sarà più un mantra ma una solida realtà da mantenere a tutti i costi.
Legare PIL e transazioni finanziare direttamente con il benessere materiale delle persone sarebbe catastrofico dal momento che siamo pienamente inseriti in un sistema che induce bisogni inutili sempre più costosi.
Senza contare che l crescita di una parte di mondo può avvenire solo a scapito di qualche altra, il che vuol dire innescare una corsa all’accaparramento di ogni singola risorsa sulla quale poter speculare, e non ci si riferisce qui alle sole risorse minerarie, ma all’acqua e alla terra, elementi scarsi ma dei quali non si può fare a meno per nutrirsi e vivere. Probabilmente nella visione apocalittica di popoli che sostengono la diretta ridistribuzione della ricchezza, proveniente dalla crescita economica indefinita e dalle transazioni finanziarie e azionarie, l’espansionismo economico sarà sostenuto come l’unica realtà possibile, tanto quanto lo è attualmente il pensiero neo-liberista.
2.2 Il reddito tra mutualismo e conflitto
 Veniamo quindi ad uno dei nodi centrali della questione, abbiamo fin qui distinto il reddito in due categorie, il reddito diretto (o monetario) e il reddito indiretto (ossia il valore d’uso di beni e servizi), il primo non è riproducibile al di fuori del mercato monetario, il secondo è riproducibile nel momento in cui si entra in possesso di conoscenze e mezzi di produzione. E’ chiaro che un percorso politico che mira all’emancipazione non può che puntare alla progressiva riduzione del primo e di un’ aumento del secondo.
Veniamo quindi ad uno dei nodi centrali della questione, abbiamo fin qui distinto il reddito in due categorie, il reddito diretto (o monetario) e il reddito indiretto (ossia il valore d’uso di beni e servizi), il primo non è riproducibile al di fuori del mercato monetario, il secondo è riproducibile nel momento in cui si entra in possesso di conoscenze e mezzi di produzione. E’ chiaro che un percorso politico che mira all’emancipazione non può che puntare alla progressiva riduzione del primo e di un’ aumento del secondo.
Siamo nel campo delle ipotesi e della speculazione teorica, un tempo definita utopia. Ma è pur vero che se da un lato il reddito serve per poter accedere a beni e servizi, nel momento in cui questi si riesce ad autoprodurli o autogestirli il fabbisogno di moneta comincia a decrescere, fino a limiti fisiologici imposti dal sistema economico e sociale nel quale si è immersi, con questo non si intende un eremitaggio di massa o un ritorno alle istanze bucoliche, ma, bensì,si intende mettere a sistema la tecnologia disponibile, e la capacità di utilizzo, miglioramento e progettazione della stessa che è polverizzata tra i lavoratori, per sopperire alle tariffe dei servizi, si intende una messa a sistema delle conoscenze per sopperire alla scarsità di servizi collettivi (ad esempio ambulatori popolari e istruzione autogestita ma anche telecomunicazioni e automazione).
E abbastanza chiaro che organizzare una qualsivoglia micro filiera produttiva è assai più semplice che autoprodurre individualmente quello di cui si ha bisogno, è sufficientemente comprensibile come la produzione collettiva sia preferibile alla produzione individuale, ma il portato socio-politico del percorso è decisamente più ambizioso. Da un lato abbiamo un percorso col quale si aggrega su istanze meramente reddituali, quindi su di uno specifico interesse, dall’altro si ha un percorso di partecipazione che coinvolge su interessi molteplici e libera una serie di potenzialità insite nel mutualismo e nei processi di condivisione.
Utopia certo, ma altrove discorsi del genere hanno permesso di impostare dei percorsi di autodeterminazione di interi quartieri o villaggi, è chiaro che debbano essere prese le giuste proporzioni prima di immaginare qualcosa del genere, ma saltarli a piè pari senza prendersi la briga di ragionare sulle potenzialità e preferire percorsi meno complessi, non sta fornendo, in termini di conflitto, i risultati sperati. Fin qui è stato sempre implicitamente posto un aut aut, o il reddito o il conflitto, probabilmente si può uscire dal dualismo, attraverso le pratiche del mutualismo conflittuale, e infine di esodo conflittuale, inserite nella riappropriazione dei mezzi di produzione e nell’autogestione di servizi via via sempre più essenziali.
3.0 Organizzazione
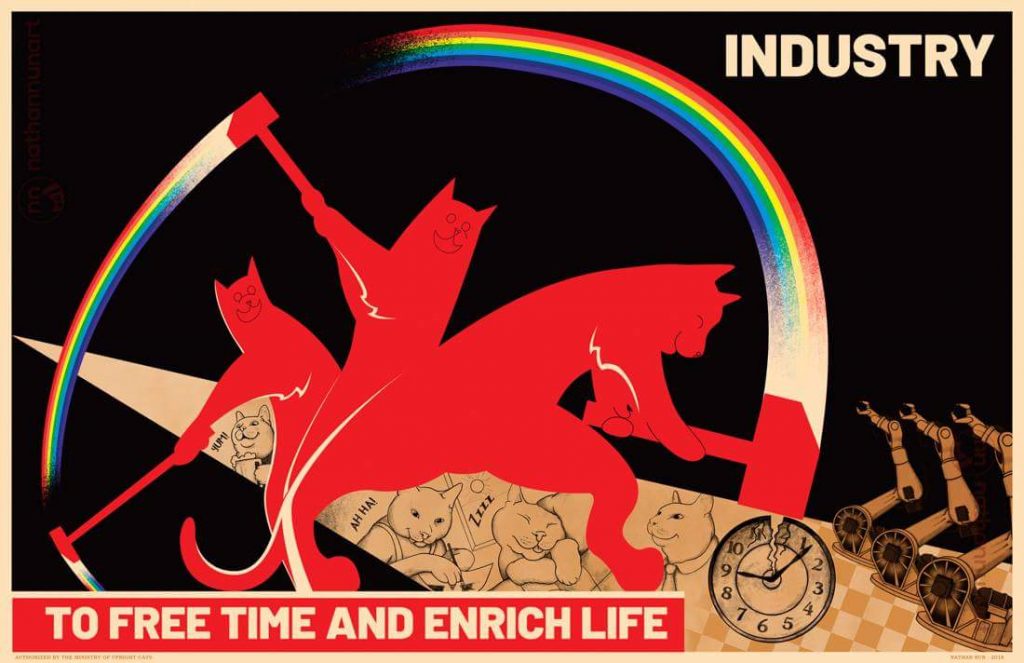 Questo è forse l’aspetto più controverso e arduo da affrontare, in virtù di quando affermato nella prima parte di questo documento, c’è stato un processo di impoverimento delle pratiche del loro contenuto teorico, e per molti versi l’organizzazione è vista, in molti settori del movimento, come un ostacolo alla libertà di espressione degli individui, con le conseguenze che tutti abbiamo sotto gli occhi. spazi sociali trasformati in ludoteche o locali notturni e progetti politici falliti per mancanza di un ricambio generazionale. Bisogna fare i conti con una generazione che non ha storia, e che non realizza una visione del futuro, quindi una generazione abbandonatasi ad un eterno presente, ad un vivere qui ed ora; e anche quando realizza una visione futura è in chiave competitiva, un prevaricare il prossimo per raggiungere lo scopo.
Questo è forse l’aspetto più controverso e arduo da affrontare, in virtù di quando affermato nella prima parte di questo documento, c’è stato un processo di impoverimento delle pratiche del loro contenuto teorico, e per molti versi l’organizzazione è vista, in molti settori del movimento, come un ostacolo alla libertà di espressione degli individui, con le conseguenze che tutti abbiamo sotto gli occhi. spazi sociali trasformati in ludoteche o locali notturni e progetti politici falliti per mancanza di un ricambio generazionale. Bisogna fare i conti con una generazione che non ha storia, e che non realizza una visione del futuro, quindi una generazione abbandonatasi ad un eterno presente, ad un vivere qui ed ora; e anche quando realizza una visione futura è in chiave competitiva, un prevaricare il prossimo per raggiungere lo scopo.
In questo scenario è veramente difficile tracciare anche solo una direzione da percorrere, sarebbe abbastanza presuntuoso indicare una via profetizzando un avvenire diverso. Ciò che è certo è che l’esempio offre ancora un certo successo nella mente di chi non trova quel che desidera nel suo quotidiano esistere, qui sono le pratiche a determinare inclusione, ma pratiche che non nascono dall’agire per l’agire, che non sono autocelebrazione dell’incapacità di creare immaginari, ma siano la naturale prosecuzione di una sintesi collettiva. La messa in atto di un percorso meditato e ragionato in maniera plurale, con una serie di concetti e punti fondamentali dai quali non si può prescindere.
Probabilmente non abbiamo ancora familiarizzato con lo sfacelo nel quale siamo immersi, primo fra tutti è il problema della comunicazione e della comunicatività a questa associata; non è un problema di cosa comunicare, ma a chi lo si comunica e soprattutto come. Le piattaforme on line sono sicuramente utili ma nel momento in cui chiunque può immettere “informazioni” in rete, dalla cacofonia o dal rumore pseudo-informativo, se ne esce seguendo solo qualche canale e lasciando perdere il resto. Non ci addentreremo nella veridicità di quanto si trova online onde evitare di scrivere un trattato, ma rimane un punto che dovrebbe essere dibattuto ossia quella tendenza ad anteporre alla narrazione del sistema una contro-narrazione altrettanto affabulatoria e fascinosa circa l’operato delle esperienze “alternative”.
Parlando quindi di “esperienze” e di pratiche, il discorso trova uno snodo critico nel quale concorrono la comunicazione, l’analisi e, infine, la sintesi operativa (una volta si definiva prassi, ma pare passata di moda). La comunicazione potrebbe in questo senso essere fraintesa come narrazione per raccontare una prassi, ma probabilmente sarebbe auspicabile all’interno della prassi si recuperassero alcuni principi base della comunicazione, comunicazione quindi come confronto che precede – necessariamente – il rapporto dialettico che introduce e scardina le contraddizioni. Il rapporto dialettico può inverarsi anche solo come prassi, nel momento in cui questa si pone come sintesi collettiva che diviene pratica. Ma tornando coi piedi nel presente, quindi fuori dalle indagini astratte, il tema dell’organizzazione e delle pratiche ad essa conducibili apre ad una serie di considerazioni che hanno come filo conduttore, la disamina dello scopo da raggiungere.
Nei paragrafi precedenti si è ragionato sulla tematica legata all’incompatibilità come filo guida delle pratiche realmente conflittuali, cadere nei ruoli di una sciarada non dovrebbe essere tra le nostre prerogative, quindi è imprescindibile una disamina di cosa sia oggi il conflitto e di rimando quali siano le pratiche realmente conflittuali. Anelare l’incompatibilità col sistema, rifiutando nel contempo tanto l’isolazionismo militante quanto la creazione di comunità chiuse in piccoli paradisi di cartapesta, dovrebbe essere la condizione di partenza attraverso la quale rileggere gli ultimi trent’anni della storia dei movimenti in questo Paese. Rileggere invece con rinnovato interesse quelle che sono le istanze del Federalismo Anarchico, anche come elemento di decostruzione di una narrazione a tratti stucchevolmente profetica del confederalismo democratico, accostandolo alle pratiche del mutualismo conflittuale, potrebbe aprire nuovi percorsi condivisibili attraverso i quali giungere ad alcune sintesi organizzative.
Al di là dei mantra dettati da slogan e parole d’ordine, fuori dall’affanno dell’inseguire date dettate da agende parlamentari, equidistanti tanto dalle istituzionalizzazioni dei movimenti quanto dall’assurda retorica dell’estetica del conflitto, probabilmente una soluzione percorribile, e che si sta già in certo modo perseguendo, è quella del recupero delle istanze più genuinamente radicali del conflitto. Ribaltare il paradigma della narrazione totalizzante neoliberista che da un lato sussurra l’impossibilità di un alternativa alla realtà, dall’altra fa dell’esclusione e dell’espulsione lo strumento per continuare a capitalizzare tutto quel comparto sociale che non può essere né produttivo né consumatore, alla stregua di materiale da riciclo. La radicalità profonda della conflittualità che non si trasforma in fuga o non diviene barricata passivamente resistente, ma conflittualità attiva che mira a portare alle estreme conseguenze le contraddizioni del sistema socio-economico nel quale siamo immersi, rimettendo tutto in discussione, a partire dal senso del reddito, finendo al significato autentico di bene comune.
Emanciparsi dal bisogno, quindi riconoscere la “scarsità” come elemento fondante della retorica neoliberista – o elemento che rende il capitale quel che è – scavalcare l’ostacolo attraverso le pratiche di riappropriazione collettiva del sapere – il cosiddetto know-how – come risposta necessaria alla decostruzione del paradigma economico, cercando di non cadere nelle trappole del contadinismo da un lato e dell’accellerazionismo dall’altro. La proposta è quella di praticare l’incompatibilità tentando di scardinare la narrazione capitalista che parla di “benefica competitività” che si trasforma in mors tua vita mea.
Tra l’Emilia, il Veneto e Internet, 5 marzo 2019
lorcon & J.R.